6. E Fu Sera e Fu Mattina

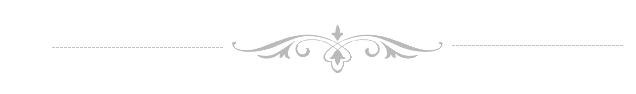
E FU SERA E FU MATTINA
di Miryel
Contando ogni passo, non si arriva da nessuna parte. Contando ogni passo, ed ogni fermata, si è statici e basta. Contando ogni passo, si perde il punto. Una ragione. Un obiettivo e Jean, in mezzo a quei cadaveri, ha appena perso l'anima. Non è sparita; non è volata via, si è solo staccata dal corpo e si è rifugiata da un'altra parte. In una casa buia, sotto ad un tavolo, dietro al lembo di una tovaglia adagiata lì chissà da quanto. Puzza di vino, puzza di carne andata a male, di sangue, di carcasse morte.
È lo stesso, identico odore che Jean sente nell'aria, da quando hanno portato a termine la missione di difendere il distretto di Trost. Il Wall Roze è salvo, molti dei suoi compagni, invece, no.
duecentosette morti e ottocentonovantasette feriti. La perdita di uomini più grossa che abbiano mai avuto e, politicamente parlando, questa è considerata una vittoria.
Eppure Jean non l'ha ancora capito, il motivo . Il motivo che lo ha spinto a tirarsi giù, in mezzo alla battaglia contro i Giganti, rischiando di morire ogni dannato secondo, divorato vivo in un attimo, come Thomas. Ha ancora davanti l'immagine di quel ragazzo, immobile, nella bocca di quel mostro, vivo e fin troppo consapevole di esserlo ancora per poco, con la speranza negli occhi di potercela fare – in qualche modo, e quella richiesta di aiuto urlata all'umanità intera.
«Non voglio morire», e poi è sceso giù, nella gola del Gigante, mangiato vivo dai succhi gastrici; logorato dall'acido. In preda alle urla? In preda agli spasmi? Maledicendolo per non averlo salvato?
È tutta colpa sua; ha preteso di essere un leader ed è finito a contare i suoi morti. Ha più anime sulle spalle che anni vissuti addosso È un dolore troppo grande, da sopportare.
Qualcosa che va oltre ogni cosa, oltre ogni morale. La vita degli altri è una responsabilità che non vuole più addosso.
Percorre lentamente quel vicolo silenzioso. Le case sono pericolanti, i civili non potranno tornarvi finché non sarà di nuovo tutto a norma. Le graziose case che caratterizzano il loro mondo sono illuminate da una leggera luce dorata. Il sole sta calando su di loro, lasciando che nemmeno la luce porti più il conforto che chiedono. I muri sono a tratti spaccati con crepe lunghissime che minacciano di aprirsi da un momento all'altro; molte delle tegole che decoravano i tetti sono spaccate a terra in mille pezzi, impossibili da riassemblare e rimettere al loro posto. Le finestre di legno sono bruciate, rotte, imbrattate di sangue. C'è odore di stantio e di carne andata a male. C'è odore di cenere – vola nell'aria e danza come se, due giorni fa, non vi fosse stata alcuna battaglia. La pavimentazione sconnessa non permette ai suoi piedi di proseguire il suo cammino con una certa disinvoltura – che comunque, in questo momento, non gli appartiene.
Conta i passi e conta i morti; quelli adagiati ai lati della strada. Nessuno di loro è intero. Ad alcuni manca la parte inferiore del corpo, ad altri quella superiore – irriconoscibili, e se fosse qualcuno che conosce? –, ad altri mancano le braccia, o parte della testa. Vede cervelli, organi interni, legamenti, ossa... le vede vive, non più pulsanti, solo penzolano da quei corpi e gli dimostrano, ancora una volta, che la vita non vale proprio un cazzo.
Ha le mani ricoperte da guanti in lattice e, sulla faccia, un fazzoletto che gli copre bocca e naso. La morte porta malattie, germi, virus, pandemie. L'aria ha raccolto ogni brandello di tossicità che quei corpi spenti emanano. La disperde e crea solo altro dolore. Qualcuno si è già ammalato; qualcuno sta già morendo avvelenato dall'aria.
Qualcuno l'ha inalata di proposito, perché è meglio morire che vivere una vita così, fatta solo di stenti, di infelicità, di un futuro che non esiste.
«Ne riconosci qualcuno?» Chiede una voce femminile, mentre Jean si guarda intorno; gli occhi sbarrati su tutta quella disperazione e quella speranza morta insieme ai suoi compagni. «Ne conosci qualcuno?» Ripete la voce, e lui si volta lentamente verso quell'infermiera, posando per la prima volta, da minuti interi, gli occhi su qualcuno ancora vivo.
«No, nessuno», dichiara, ma sa di non aver davvero prestato attenzione a quei corpi. È certo che tra di loro ci sia qualcuno che conosce, anche solo di vista; magari ci ha scambiato due chiacchiere, ci si è allenato assieme, gli ha chiesto in prestito una penna o magari gli ha urtato una spalla, una volta. Un rapporto blando, uno di quelli per cui non dovrebbe soffrire, se qualcuno che non conosce bene muore.
Solo che la morte fa troppo parte della sua vita, per poterla ignorare, o sminuire, o tentare di non guardarla in faccia.
«Se vedi qualcuno che conosci, non perdere tempo e segnalamelo. Stiamo cercando di chiudere la cernita nel minor tempo possibile. Lasciarli qui significa esporre la popolazione ad un ulteriore rischio: dobbiamo bruciarli, e dobbiamo farlo prima che sia tardi», dice ancora la ragazza, e usa un tono di voce duro e distaccato: qualcosa che Jean odia e che invidia da morire. Vorrebbe essere così: distante. Vorrebbe prendere tutta quella storia in maniera meno sentimentale e più pragmatica. Lo è sempre stato, fermo nelle sue convinzioni; ha fatto le sue scelte, e la strada facile era la sua unica salvezza. Poi ha combattuto contro quei mostri, ha perso troppe persone, e ora non sa più cosa vuole.
«Non è facile, siamo ancora tutti storditi dalla battaglia», replica, tentando di ritrovare se stesso in quelle parole dure, ma non ci riesce. Jean è distante, è altrove. È ancora tra i tetti a veder morire i suoi compagni; è dentro una casa in attesa che quel Gigante se ne vada via. È nella bocca di uno di quei mostri, al posto di Thomas, e viene divorato vivo.
Jean è avvolto dai succhi gastrici e il dolore lo sta digerendo .
«Abbiamo perso più uomini di quanti se ne possano immaginare; cedere ora significa sprecare il loro sacrificio. Non c'è tempo per lasciarsi prendere dai sentimentalismi. Non è ancora finita. Quando avremo un quadro completo, allora potrete crollare ma ora... ora è necessario che anche voi restiate vigili. Capisci cosa voglio dire?»
Sii ancora il soldato che obbedisce agli ordini, Jean. Non puoi ancora chiuderti in quel fienile e reprimere i singhiozzi e a lasciare che il mondo ti crolli addosso, perché ogni scelta che farai è sbagliata. Non ancora. Non è tempo. Non è ancora tempo.
Cerca di rizzarsi sulla schiena e, con un pugno chiuso sul cuore, obbedisce all'ordine. Si guarda intorno, ma non ci riesce lo stesso, a dare un nome a quei volti tumefatti e decomposti. Sembrano tutti dannatamente uguali.
«Ci sono molti dispersi, ancora. Il corpo di ricerca si è messo in moto per cercarli tra le macerie e nei pressi del Wall Roze. Nel caso ci fosse bisogno di ulteriori riconoscimenti rimani disponibile, soldato», dice ancora la ragazza, e non attende nemmeno che Jean risponda. Si gira di scatto e torna a lavoro. Conta i morti indicandoli con l'indice e poi li segna su un foglio.
Sono numeri. Numeri e basta. Nessuno li ricorderà in altro modo.
«Jean?» È la voce di Connie, che lo ridesta. Quando si gira a guardarlo, quasi non lo riconosce. Accanta a lui c'è Sasha, ma nessuno dei due ha voglia di ridere, di scherzare, ed è questo il momento in cui si rende conto di quanto la guerra cambi le persone; di quanto il dolore, a volte, non si riesca a celare dietro nessuna maschera. Si guardano per minuti che sembrano interminabili, poi Connie parla, e fa un passo verso di lui. Jean sente l'impulso di indietreggiare, ma resta fermo, come se i piedi fossero cementati nel terreno. Non riesce a fare un solo passo; non riesce nemmeno ad aprire la dannata bocca. Non riesce a fare un cazzo di niente, perché ha paura.
Non sa cosa sta per dirgli Connie e forse non vuole saperlo. Sposta su Sasha i suoi occhi interrogativi, ma lei è silenziosa. Guarda i morti ai lati delle strade; vede i suoi occhi riempirsi di lacrime, ma non piange.
«Come stai?», chiede infine Connie e Jean torna a guardarlo.
«Che cazzo di domande fai?» È più forte di lui, non riesce a rispondere quando c'è da esporsi così tanto. Non è quello che vuole, tirar fuori i sentimenti. Non ci riesce con tutti, forse con nessuno, per quello decide di chiedere, con il cuore che gli pompa sangue più velocemente di prima...
«Dov'è Marco?» Non gli interessa di risultare disinteressato al resto del mondo. Non ha chiesto loro come stanno, non ha domandato a nessuno come vada. Non lo ha chiesto nemmeno a se stesso, ma è quella la domanda che gli frulla per la testa da quando tutto è finito.
Dove cazzo è Marco? Che fine ha fatto? Dove lo avete portato? È vivo?
È così difficile attendere una risposta e, allo stesso tempo, è difficile immaginarla. Spera solo che non sia come pensa, ma una speranza ce l'ha. Marco non è lì, tra i caduti e, a meno che un gigante non l'abbia divorato – ha un brivido al sol pensiero – allora forse una speranza c'è. Una cazzo di speranza c'è.
La sera è quasi giunta, il sole sta calando. È quasi buio, e non vuole rimanere lì. Connie è silenzioso, Sasha guarda ancora i cadaveri, allora li incalza. «Allora? Se devi dirmi che è morto dimmelo subito e togliamoci il pensiero.» Non lo pensa davvero, sa che se dovesse dirgli davvero quello che pensa, ovvero che Marco non c'è più, non sarà un pensiero che si è tolto, e nemmeno un peso. Sarà la fine, e questo è certo.
«È... in un centro medico, tra molti feriti. Ha subìto dei danni, ma è vivo. Non ancora cosciente, ma vivo.»
È vivo. Quasi basta questo per dargli una speranza. Ha subito danni, non è cosciente, ma è vivo e questo significa che, almeno la battaglia, per lui, è vinta. Marco ha dimostrato di sapercela fare, dopotutto qualcuno lo ha scelto come il Capitano del corpo cadetti e, anche se Jean non era d'accordo, al tempo di quella decisione, ora si rende conto che forse, meglio di lui, non potevano sperare. Tira un sospiro di sollievo silenzioso, attende qualche secondo di silenzio e cerca di riprendere in mano il suo lato distaccato da ogni cosa, ma è evidente che si è tolto un peso, stavolta per davvero, anche se una piccola parte di sé gli ricorda che Marco ha subito dei danni e che questo non significa per forza che sopravviverà.
Non chiedere è la cosa migliore. Vuole vederlo, anche se ha paura di scoprire che si trovi nella situazione peggiore in cui può trovarlo ma, dopotutto, ha affrontato i Giganti. Affrontare la paura di perdere una persona così importante non dovrebbe essere peggio di quello, no?
No, non dovrebbe, eppure lo è.
«Posso vederlo?»
«Sì, sì. Annie si è offerta di stare con lui finché non sarà tutto sistemato.»
«Annie?», chiede, e la cosa lo sconcerta. Perché proprio Annie, a cui non è mai importato niente di nessuno, figurarsi di Marco.
«L'ha trovato lei. Lo ha portato al centro medico. Sembrava in stato di shock, non so dirti il perché. Mai vista Annie in quel modo.»
Ci sarebbero tante domande da fare, in questo momento, a proposito di Annie che salva Marco e lo porta al centro medico e lo accudisce. A Jean è parso di vederla poco o niente durante tutta la durata della battaglia, ma è anche vero che è stato uno scontro difficile dove, ad essere sinceri, il sentimento più forte che ha provato è quello della solitudine.
«Andiamo», dice solo. Poi fa un passo e si ferma ancora. «Gli altri? Dove sono?»
Stavolta è Sasha a parlare. Si sistema meglio il fazzoletto che sta usando come protezione dalle polveri tossiche e, con un colpo di tosse che le serve a schiarirsi la gola, sembra assente.
«I giganti hanno fatto irruzione, ma Eren è riuscito a bloccare la breccia con il masso. Il problema ora è che ora lo hanno catturato e rinchiuso. Ci hanno interrogati tutti, probabilmente lo faranno anche con te. Vogliono sapere il più possibile su ciò che sappiamo a riguardo.»
«Non mi importa un accidente di Eren. Ha fatto solo il suo dovere, perché lo hanno rinchiuso?»
Connie sospira. «Jean, è un Gigante. La contraddizione sta nel fatto che noi li combattiamo da sempre. Lui è un'eccezione, certo, ma resta comunque un Gigante e questa è un'aggravante. I piani alti sono divisi in due, tra chi vuole ucciderlo e chi vuole sfruttarlo come potenza bellica. Per ora è rinchiuso, anche se incosciente, per evitare che possa creare ulteriori danni.» Il concetto è chiaro, ma se davvero Eren ha dimostrato di poter controllare il gigante, perché dovrebbero temerlo? Combattere il nemico con la stessa moneta è in vantaggio, no?
Non lo sa nemmeno lui, in verità, qual è la cosa migliore. La ragione gli dice che è una follia stare solo a pensarci, che quello non possa essere un vantaggio, dall'altra il cuore vuole sapere come sta Marco. Così annuisce e si lascia guidare fino al centro medico. Più si allontanano dal distretto di Trost – che ormai ha completamente perso l'aria di casa che, per lui, ha sempre avuto, più l'aria si fa meno tossica. Seguono una via fatta da un sentiero di pietra e, attraversando un arco e proseguono sullo stesso sentiero, fino ad arrivare di fronte ad una grossa struttura, che Jean riconosce come l'ospedale locale.
Guarda in alto, e tutto sembra troppo silenzioso, ma sa che quando entrerà le urla di dolore e i lamenti dei sopravvissuti lo coglieranno. Lui se l'è cavata con qualche graffio; gli fa male il polso destro, ma nulla di che. Se non ci pensa il dolore sparisce. Gli fa male la testa, ma è il male minore, sta bene. Sta meglio di quanto potesse anche solo immaginare all'inizio di quella battaglia. Connie e Sasha lo superano, entrando nell'ospedale, lui si risveglia da quei pensieri e li segue; non ha mai visto quei due così seriosi.
Il piano terra è solo un centro accoglienza, ma ci sono varie barelle ai lati dei muri, tutte piene. C'è chi ha perso degli arti e urla di dolore, mentre qualcuno gli sta vicino e cerca di dar loro coraggio. C'è chi è incosciente, ma respira. Jean si premura che lo facciano. Gli infermieri e medici corrono di qua e di là, senza sosta. Nessuno dà loro importanza, e forse è meglio così.
Al primo piano la situazione è simile, ma a Jean è sembrato di sentire dei lamenti meno forti, meno dolorosi. Non sa dire se qui ci siano malati meno gravi, o persone morte. Spera di no, spera nella prima. Si rende conto di star sperando troppo, da quando è entrato lì dentro e, per uno realista come lui, è quasi una sconfitta.
Ogni scalino che sale, il respiro di accorcia e il petto gli fa male ma, dopotutto, Il battito del cuore è indice di sentimenti, o almeno così gli ha detto Marco, una volta, stretto – avvinghiato al suo petto, come se fosse la sua unica ancora di salvezza.
Percorrono un corridoio quasi vuoto, e ancora una volta Jean si chiede se sia un buon segno oppure no; Connie e Sasha tacciono, non sono mai stati così silenziosi da quando li conosce. La battaglia di Trost è stata un colpo per tutti, persino per loro. Ha cambiato troppe cose, forse per quello, quando arrivano di fronte alla stanza di Marco, lo lasciano solo. Connie vuole andare altrove, dice di avere fame; Sasha lo segue, e la scusa del cibo, stavolta, è solo una scusa, forse. Non è la verità, come al solito. Persino lo stomaco di quei due è riuscito a chiudersi.
«Lo abbiamo già salutato», si giustifica Connie, e Jean si chiede se glielo stia dicendo per giustificarsi del perché non vuole entrare o gli stia dicendo indirettamente che, Marco, in quello stato non lo vuole vedere.
Ma a Jean non importa. No, non è vero, gli importa, perché a volte le emozioni gli si leggono in faccia e non vuole che Marco pensi che stia soffrendo per lui, che lo reputi debole. Dopotutto si sente responsabile di ciò che è successo a tutti, perché sa di aver potuto fare di più e non l'ha fatto. Si è solo nascosto, per un tempo infinito, in una casa, per poi uscirne vivo per miracolo. Non è l'eroe che tutti pensano, né tantomeno il leader che decanta sempre Marco.
Con quel pensiero pessimistico annuisce, e saluta i due, sempre in silenzio, poi entra nella stanza, perché la porta è aperta e c'è un unico letto, solo che non vede niente: una tenda bianca separatrice cela Marco e non glielo fa vedere immediatamente. Quando la supera, un passo dopo l'altro, con le ginocchia che gli tremano, la prima cosa che vede è Annie seduta su una sedia, che legge un libro, e veglia sul malato.
Lei alza la testa, evidentemente percependo la sua presenza, e la sua espressione non cambia di un millimetro.
«Che ci fai qui?», chiede Jean.
«L'ho trovato io.» Risponde, laconica e quasi sembra glielo stia facendo pesare.
«Non ti ho chiesto chi l'ha trovato, ti ho chiesto cosa ci fai qui.»
«Non c'era nessun altro che potesse esserci. Non fraintendermi, è una gran bella scocciatura, ma non avevo altra scelta se non restare io, visto che tu non c'eri.»
«Io stavo contando i morti, mi davo da fare lì fuori! Non ero di certo qui con le mani in mano!»
«Kirschtein, perché non mi ringrazi semplicemente invece di prendertela sul personale siccome non lo hai trovato tu?», domanda lei e lo prende dritto al cuore, quella freccia avvelenata. Perché sì, forse nemmeno lui c'ha pensato, e Annie forse non gli piace così tanto come persona, ma avrebbe voluto trovarlo lui – anche se magari non lo ha salvato da quello che gli è successo, però almeno lo avrebbe accompagnato lì, gli sarebbe stato vicino e al diavolo tutto il resto.
Perché sì, Jean lo sa, che l'unico motivo per il quale si è messo a fare la cernita delle morti in battaglia è stato per ritrovare Marco, dato che non aveva notizie di lui. Deglutisce un groppone e si prepara al contrattacco, perché non gli sta bene che gli si dica la verità in modo così brutale e sa che Annie, in questo, è molto più capace di lui.
«Annie...», sibila Marco, dal suo giaciglio, e Jean si rende conto che non lo ha ancora guardato. I suoi occhi schizzano immediatamente verso quelli del compagno, che sta cercando di alzare la testa dal cuscino. Ha la testa fasciata, la parte destra del corpo completamente coperta di bende, così come anche l'occhio. È bianco come il lenzuolo nel quale è avvolto, ma sorride. Marco sorride sempre e a Jean, questo, fa sempre tanta rabbia, perché lo sa... lo sa quanto muore dentro, quanto soffre, quanto ha bisogno di essere rassicurato, sebbene sia lui quello che lo fa sempre per gli altri.
Annie lo guarda a sua volta. Si dicono qualcosa in quel silenzio che intercorre tra di loro, poi lei chiude il libro con un tonfo sordo e si alza. Annuisce verso Marco che le sibila un grazie a mezza bocca, ma lei non risponde. Si volta verso Jean, resta qualche secondo a guardarlo, monoespressiva.
«Non farlo stancare.» Pare un ordine, più che un consiglio, e nota una leggera vibrazione preoccupata nella sua voce, ma non fa in tempo a rimuginare su quel fatto, perché lei se ne va. Quando esce dalla stanza, e Jean ha seguito tutta la sua traiettoria, resta immobile a fissare la porta aperta, che dà sul corridoio, dal quale ogni tanto spunta qualche medico o infermiere che fa avanti e indietro.
«Jean», lo chiama Marco e lui si ricorda finalmente del motivo per il quale è lì. Si volta e Marco sorride ancora, ma è un gesto pregno di malinconia che non sa proprio come cancellare dal suo viso. Non è mai stato capace di farlo con nessuno, forse non gli è mai importato, ma con Marco...
Si siede sulla sedia che fino a poco fa era occupata da Annie, ed è Marco a prendergli una mano, quella non fasciata, la sinistra.
«Come stai?» È Marco, a chiederglielo, quando avrebbe dovuto essere lui a fargli quella domanda.
Annuisce, e mente. Non sta bene per niente. Non si sente al sicuro, non si sente bene. Si sente confuso, e non sa nemmeno perché.
Annuisce ancora e abbassa lo sguardo. Fissa le bende.
«Tu come stai, piuttosto.»
«Jean, hai appena detto di aver fatto la cernita delle perdite.»
«Sono duecento sette, almeno per ora. E... tra questi non ci sei tu, quindi va bene.» È dura ammetterlo, ma Jean si autoconvince che questo è ciò che Marco vuole sentirsi dire, quando la verità sta nel mezzo. Questo è quello che lui vuole sentirsi dire, solo per fingere che non lo stava davvero perdendo, che comunque è lì davanti a lui, parla – piano, pianissimo, ma almeno parla. «Connie mi ha detto che non eri cosciente.»
«Mi sono svegliato questa mattina», gli stringe di più la mano. «E ho trovato Annie.»
«Perché è rimasta qui?»
«Credo perché è stata lei a trovarmi.»
«Sai cosa intendo dire.»
Marco alza strabuzza l'unico occhio che ancora si vede e, con le sopracciglia aggrottate, scuote la testa. «Ad essere sinceri, non lo so.»
Jean ci crede, anche se in quella breve frase ha sentito qualcosa che somiglia ad una bugia; forse non del tutto tale. Non gli sconfinfera l'idea che, tra tutti, proprio Annie sia rimasta al suo capezzale. Lei, che è sempre insieme a quei due, che non si separano mai. Lei che ha creato una bolla intorno a sé e non ha fatto altro che allontanarli tutti quanti da lei.
«E Reiner e Berthold?»
«Non lo so, Jean. Non me ne ha parlato.»
«Li ho visti per un attimo a Trost, mentre facevano il conteggio. Mi sembrava di aver visto anche Annie, forse mi sono sbagliato.»
«No, era con loro. Mi ha detto che, quando sono venuti Connie e Sasha a trovarmi, ne ha approfittato per riposare. Forse me lo ha detto per non farmi preoccupare.»
«Non è da Annie.»
«No, non è da Annie.» Marco non lo guarda più, ma non sembra avvezzo a voler continuare quella conversazione su Annie. Tiene per sé le parole, le incastra nei denti e tace. Non vuole parlare e si vede. Non vuole parlare di lei, gli pesa o – Jean lo sa, sembra assurdo, sembra quasi ne abbia paura.
«Che cosa è successo?», chiede infine, cercando di cambiare argomento, anche se non gli interessa così tanto il come , gli piacerebbe sapere di più perché Marco è in quelle condizioni. Sta facendo finta di niente, ma in realtà lo vede soffrire ed è palesemente anestetizzato da qualche medicina. Accanto al comodino ci sono una quantità di pillole; alcune le riconosce, altre no. Sono per lo più per il dolore, alcune per l'umore. Le conosce bene, le prendeva sua madre, quando è rimasta sola con lui, anni fa.
Antidepressivi, forse. Non è difficile credere che, dopo un danno simile, Marco ne abbia bisogno, solo che è impossibile da accettare.
Eppure è vivo e vegeto, di fronte a lui. Depresso, sconfortato, buttato già, incredulo, forse nemmeno totalmente presente, ma è vivo. Questo conta. Conta questo e nulla più e Jean vorrebbe abbracciarlo e basta, dirgli che non gliene frega niente di come è successo e perché e cosa. Non gli interessa sapere che ha sofferto e lui non era lì ad aiutarlo, pronto a difenderlo. Pronto a dare la vita. No. No, è un codardo, forse questo non lo avrebbe mai fatto. O forse sì. Non lo sa, non potrà mai saperlo, e non vuole immaginarlo, ma non può farne a meno, e vorrebbe dirgli di dimenticare quella domanda e tacere, anche solo per un istante, e dirgli che va tutto bene, che malgrado tutto la cosa importante è essere lì, insieme, e fingere che là fuori non ci siano i Giganti pronti a colpire ancora, ad attaccare, a mettercela tutta per distruggere tutto quello che sono riusciti a creare.
Ma Marco non tace. Apre la bocca, poi abbassa lo sguardo. Lo rialza, si morde l'interno della guancia, poi sospira. Poi tace ancora, e infine lo dice, e Jean vorrebbe tapparsi le orecchie e guardarlo soltanto e sperare che, ad un certo punto, gli sorrida e basta.
«Mi ha quasi divorato un gigante. Mi ha... morso questa parte del corpo. Con i dente mi ha...», si blocca, alza una mano verso la benda che copre l'occhio, e trema, «mi ha perforato la pupilla. Ho... perso la vista, almeno da questo lato. Mi ha spezzato qualche legamento del ginocchio; anzi, quello è proprio spappolato e, nulla, sono quasi morto, Jean», conclude, e finalmente lo guarda. L'occhio sano lucido, che trattiene le lacrime di un dolore che è sia esterno che interno. «Non ricordo niente, so solo che ho urlato, qualcosa mi ha tirato via dalla bocca del gigante e mi sono ritrovato a terra. Ricordo solo Annie che mi aiuta ad alzarmi e mi porta al sicuro dentro una casa. Poi è sparita; non so se sono passate ore o solo pochi minuti, ma quando è tornata mi ha portato qui. Mi hanno soccorso immediatamente e lei mi è rimasta accanto, incantando i medici a fare il possibile. La sentivo, era arrabbiata, voleva che facessero di più.»
«Perché?», chiede Jean, anche se ha appena assimilato tutto quel racconto, ad occhi chiusi, immaginando Marco, da solo, lontano da lui, che viene preso da un gigante e si sente solo, mentre quello quasi lo divora. Quasi lo spezza.
No, un po' lo ha spezzato, in due. La parte destra di Marco, sotto quelle bende, forse non esiste nemmeno più. È come un arto fantasma.
«Non lo so. Davvero, non lo so perché l'ha fatto.» Invece sembra saperlo, e sta violando quella promessa che si sono fatti, un giorno, dentro un fienile dove hanno fatto l'amore e dormito abbracciati. In un luogo che è sempre appartenuto a loro e dove si sono giurati sincerità, sempre, perché i traditori sono ovunque, ma loro due non hanno motivo di tradirsi.
Forse mente per difendere Annie, forse mente per difendere sé stesso. Forse mente per difendere Jean, e questo sembra quasi un motivo per non continuare ad indagare. Non attraverso di lui e, forse, non è nemmeno il momento di farlo. Chiude di nuovo gli occhi, poi li riapre e sospira. Si guarda intorno, spaesato. Non sa cosa fare, non sa che domande porre, non sa come guardarlo, non sa come comportarsi.
Poi però è Marco che gli fa una richiesta, che lo spiazza perché, se c'è una cosa che Jean ha dimenticato, ora come ora, è che il resto è fuori da quella stanza e, di fronte a lui, c'è ancora il ragazzo di cui si sta innamorando.
«Mi puoi baciare, per favore? Ho proprio bisogno che mi baci. Voglio sentire che ci sono ancora.»
«Ma tu ci sei ancora, Marco», cerca di rassicurarlo, e gli accarezza una guancia, con un sorriso che sa di amarezza e, allo stesso tempo, di dolcezza.
Se un bacio può risanare qualcosa, lo farà per entrambi, anche solo per un instante, ma funzionerà. Ha sempre funzionato, dopotutto, tra di loro.
Si china e gli bacia le labbra, le assaggia, le divora, e poi stringe gli occhi, mentre approfondisce quel contatto e sente, sulla mano che ancora circonda la guancia di Marco, le sue lacrime. Lo coccola, si stacca, gli dice che va tutto bene, che il dolore passerà, che è ancora tutto assurdo ma ce l'hanno fatta e questo conta. Prima o poi la guerra finirà, ma devono ancora viverla come se fosse passiva, quella vita, perché lasciarsi trasportare dalla realtà dei fatti è solo un modo più doloroso di autodistruggersi.
Marco prega, a volte, e questo Jean non lo capirà mai a pieno, ma ultimamente giustifica quell'azione: sa che a qualcosa serve, almeno a lui, e che lo fa andare avanti. Ha un motivo per farlo, per proseguire, per lottare e per rispondere alla domanda più importante:
Perché lo facciamo? Perché ci buttiamo nella mischia e quasi cerchiamo di farci uccidere, tentando comunque di salvare tutti? Perché, poi, alla fine non salviamo mai nessuno?
Avrei voluto salvarti io , pensa Jean, e ci sta male, a quel pensiero, non gli piace l'idea di aver fatto l'eroe in disparte dimenticandosi di Marco. No, non è vero, non lo ha mai dimenticato; non è vero un cazzo, lo ha cercato sempre, ha tentato di tenerlo sempre d'occhio e quando l'ha perso di vista ha temuto il peggio e lo sa... lo sa perché ha lottato tanto per sopravvivere. Lo ha fatto per premurarsi che anche a Marco fosse toccato lo stesso destino.
Gli è toccato, certo, è di fronte a lui, vivo ma a metà, quasi morto, quasi divorato, ora un ricettacolo di paure e paranoie, di sensi di colpa per non avercela messa tutta e, forse, lo stesso senso di abbandono che ha provato Jean quando non erano più assieme. O che, alla fine, non si sono sostenuti a vicenda come si erano promessi.
Dannazione, se solo non si fossero tolti l'uno gli occhi dall'altro, nemmeno per un secondo, ora magari Marco starebbe bene, sarebbe intero.
Oppure, chissà... forse sarebbe morto per difenderlo, per aiutarlo ad uscire da quella casa nel quale Jean si è rifugiato come un codardo, prigioniero di quattro mura, dei propri pensieri e costretto a rubare ad un cadavere senza volto un'attrezzatura, solo per sopravvivere. La guerra è anche questo: spegnere il cervello e lasciar andare il corso delle cose.
Vince la legge del più forte, e questo è ciò che Marco deve capire – anche se non ci crede nemmeno Jean: loro sono forti, loro ce l'hanno fatta; loro sono quei pochi che possono dire di aver superato la morte, di averla sconfitta, di averla schiacciata, anche se lei ce l'ha messa tutta per prenderli con sé e forse – sì, forse non smetterà di provarci e la prossima volta ci riuscirà, ma questo è un problema di dopo. Di domani. Jean vuole che almeno quella notte passi, il giorno arrivi e che ci pensi poi. Ora non è il momento di lasciarsi travolgere dalla paura del futuro, perché... perché a volte ha l'impressione che un futuro non ci sia per nessuno di loro e allora tanto vale godere degli attimi che gli sono concessi.
Solo che Marco sembra preoccupato per altro, sembra più impaurito che stanco; sembra quasi che per lui, l'incubo, sia un altro.
Per ora non importa, indagherà più avanti, ma non è questo il momento, resta con lui. Almeno fino al giorno dopo.
Così, si fa sera e poi mattina, e sono ancora insieme, per un altro giorno ancora. Quanto basta per dire al mondo che non è ancora tutto perduto e che, il destino, non ha ancora scelto di dividerli.
FINE
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro