44. Saper perdere
Qualcosa di freddo la risvegliò bruscamente.
Lì per lì non riuscì a comprendere se fosse stata un'altra secchiata d'acqua o qualcosa di diverso.
Sentiva di non appartenere più a quel mondo, non del tutto.
Aveva addosso l'odore di Ulrik, il suo profumo, il suo respiro calmo, quieto.
Ci mise qualche istante a mettere a fuoco la figura che si era inginocchiata al suo cospetto.
Era fradicia, ma non sapeva dire se fosse sudore, sangue o l'acqua non ancora evaporata. Sbatté le ciglia più volte, frastornata da un qualcosa a cui non sapeva dare un nome.
Il dolore era distante, ovattato. I nervi non erano mai stati così distesi.
Soppesò l'idea di tornare nell'oblio, tra le sue braccia.
Le sarebbe bastato chiudere di nuovo le palpebre pesanti.
Ma dallo sguardo della donna comprese che non gliel'avrebbe permesso.
«Lui ti vuole vedere. È mio compito renderti presentabile.»
Non si mosse, non tentò di afferrarla. Evangeline sapeva di aver bisogno di aiuto per rialzarsi. Con le mani e i piedi intorpiditi e legati, le era impossibile ergersi in piedi da sola.
Chinò la testa di lato. Non c'era paura sul suo volto. Non più.
Dolore e paura erano emozioni sconosciute, le ricordava di nome, ma non sapeva dar loro una forma, una consistenza.
Poteva tornare da Ulrik quando voleva, di questo era certa. Lì non c'era niente d'interessante.
Niente che le appartenesse, non più.
Eppure decise di restare, di soffermarsi su quella squallida realtà angusta e maleodorante.
Forse qualcosa di remoto la spinse in quella direzione, la tenne sveglia.
Anche la donna chinò il capo per soppesarla, ma dalla parte opposta alla sua.
«Hai ucciso il mio compagno» le rivelò.
Evangeline rimase muta. Non sapeva di cosa stesse parlando.
La donna se ne rese conto e fremette d'ira. «L'uomo che hai sgozzato nei bagni.»
Era ancora un uomo, quindi?
L'Umana si tenne per sé il quesito.
Non ricordava nulla, era tutto troppo nebuloso.
L'aveva fatto? Era stata in grado di compiere un simile delitto? Proprio lei che aborriva le armi da fuoco perché aveva paura di nuocere per errore?
«E Connor... quello che gli avete fatto...» Scosse la testa addolorata.
La ragazzina resse lo sguardo con una spavalderia involontaria.
Non conosceva nessuno con quel nome.
«Loro... loro ci hanno fatto cose atroci, loro ci hanno costretto a guardare mentre facevano cose atroci. Ma voi... voi siete peggio. Voi siete degli animali! Ci avete attaccati nel cuore della notte, avete triturato i nostri corpi e fatto esplodere l'area centrale! Voi siete delle bestie! Siete dei demoni! Dopo tutto quello che avevamo subito, dopo quello a cui eravamo sopravvissuti... non meritavamo un finale del genere. Nessuno lo merita. Nessuno...»
Era tutto così assurdo e incoerente.
Eva non replicò, non tentò di discolparsi, optò per il silenzio.
Dentro di lei voci sconosciute le suggerivano di non svelarsi, di recitare una parte rassicurante e remissiva, di non combattere ma di rimanere in allerta.
Un singhiozzo sfuggì dalle labbra screpolate della donna. «Lui era buono con me, non come gli altri. Non era una bestia, sapeva essere gentile. Tu sai cos'è la gentilezza? Ricordi il suo sapore?»
Aveva occhi vitrei, assenti.
Non si scompose non ricevendo risposta.
«Lui ti vuole vedere. Sarai il suo giocattolino. Ha sempre sognato di catturare un Umano. Sarà felice di sapere che sei una dolce ragazzina, un bel bocconcino.» Con le unghie le arpionò il viso.
Eva socchiuse la bocca, pronunciò un suono debole, ma deciso. «Lui ha un nome?»
La donna rimase sconcertata dal tono fermo, incongruente col fisico emaciato, distrutto dall'esterno e dall'interno.
«No, loro non vogliono essere chiamati con alcun nome.»
Eva annuì. «E tu? Tu ce l'hai un nome?»
La donna deglutì a fatica. «Sofia» mormorò senza comprenderne il motivo.
La odiava, la voleva vedere piegarsi, spezzarsi, soffrire tutto il male che lei aveva sofferto. Eppure era ipnotizzata da quegli occhi cangianti tra il verde e il marrone. Occhi puri e severi, occhi sinceri, occhi che non avevano nulla da nascondere, nulla da temere.
«E il tuo compagno come si chiamava?»
Qualcosa le si spaccò nel petto, avvertì il rumore della lacerazione.
«Christian.»
Era tutto sbagliato, tutto orribilmente sbagliato. Senza volere strinse ancor più forte la mascella della ragazzina, la graffiò con le unghie nere di sudiciume.
Lei non si oppose. «Arca?» chiese.
«Arca A-04. Seconda missione.» Trasse un profondo sospiro, l'aiutò a rialzarsi. «Vieni ora, è giunto il momento.» La afferrò sotto le ascelle e la sollevò dal pavimento.
Evangeline le rivolse un sorriso tenero e infantile.
Sofia rabbrividì.
❈
Ulrik teneva un bastoncino di liquirizia in bocca, sospeso tra le labbra. Gli aveva consigliato di mangiare quella sera, ma lui stesso si era mantenuto a digiuno.
Era vigile, lo sguardo proiettato davanti a un edificio decadente divorato dall'edera, immobile come un blocco di marmo, sembrava un antico gargoyle.
Avevano marciato attorno all'ex-campo di addestramento dall'alba al tramonto. C'era stato fermento, in molti erano morti nell'esplosione, ma non tutti.
Adam non aveva saputo quantificare il numero delle vittime e dei superstiti, ma contava che il comandante lo sapesse fare.
Anche se non gliel'avrebbe rivelato. Non si erano rivolti parola. Nemmeno un grugnito, un cenno, un'occhiata di sbieco.
Il ragazzino provava un senso di straniamento nello stare al suo fianco. Era come se non esistesse, come se in realtà fosse solo la sua ombra. Temeva di svanire nel nulla al calare delle tenebre. Temeva si fosse dimenticato della sua presenza.
Tutti si sarebbero dimenticati della sua esistenza, Eva compresa.
Chi si sarebbe ricordato dell'Umano debosciato che aveva fatto fallire la missione? Chi avrebbe pianto per lui? Chi l'avrebbe sognato.
Non aveva osato interpellare Ulrik, porgli questioni. Era già tanto che l'avesse coinvolto, che non l'avesse respinto, che non gli avesse ordinato di tornare dal gruppo.
Però quel silenzio lo sfiniva. Avevano girato in lungo e in largo, avevano perlustrato ogni zona, monitorato i movimenti, preso appunti mentali. O almeno, si augurava che Ulrik l'avesse fatto. Adam non aveva capito molto, solo che c'era una palazzina in cui vi era più fermento rispetto alle altre. Brulicavano Arcadiani, armati, mascherati, ma visibilmente ancora appartenenti alla loro specie, riconoscibilmente uomini e donne.
Di Antichi non ne videro nessuno. Si nascondevano, lasciavano ai sottoposti il lavoro sporco di radunare i cadaveri, dargli fuoco e sorvegliare l'area.
Ulrik aspettava. E questo lo innervosiva.
Cosa diavolo stava aspettando?
Certo, intuiva che un'azione repentina, non pianificata, burrascosa e avventata li avrebbe condotti tutti e due a una rovina certa. Ma d'altra parte... qual era il suo piano?
Cosa sperava di ottenere? Dove voleva arrivare?
Adam raccolse un grumo di saliva e la sputò a terra. Ulrik non fece una piega, finse di non accorgersi che gli schizzi gli erano finiti sugli stivali di cuoio.
«Potrebbe essere già morta.»
Lo vide irrigidirsi, ma non ottenne altra reazione.
Non stava succhiando il bastoncino di liquirizia, non lo mangiava, non lo masticava. Lo teneva sospeso, assorto, come fosse una sigaretta. Il che era davvero strano perché era certo che uno come Ulrik non avesse mai fumato in vita sua e non intendesse farlo proprio ora.
«Mi hai sentito?!» Prese un profondo respiro. La sua indole stava per avere la meglio. I dottori sull'arca si sarebbero congratulati con lui per aver resistito così a lungo. Lui no. Non si congratulava né con loro né con se stesso per essere diventato il mostro di cui poteva ammirare il riflesso nelle iridi gelide del comandante.
«Sì. Ti ho sentito.»
Provò un brivido di gelo e un fremito di tiepido sollievo. Allora esisteva ancora, dopotutto. Aveva pensato di essere sparito. Aveva sospettato di essere morto e di averlo dimenticato. Aveva temuto fosse tutto perduto.
«Qual è il piano?» La domanda fatidica, quella di cui non era certo di voler conoscere la risposta.
Ulrik prese tra i denti il bastoncino, lo fece inclinare verso l'alto e verso il basso, assottigliò gli occhi rivolti in un'unica direzione: quel dannatissimo edificio diroccato in cui tutti entravano e nessuno usciva.
«Oh! Mi rispondi?!»
Non sopportava la latenza, il fatto che fosse così calmo e imperturbabile.
L'avrebbero potuta picchiare, torturare, stuprare, uccidere... e lui se ne stava lì, come un corvo appeso a un ramo, ad aspettare.
Ma che cazzo stavano aspettando di preciso?
«Un piano» ripeté il comandante tra sé e sé, come se la parola gli giungesse nuova. «Non ho nessun piano, Hollander.»
Il ragazzino ebbe un tic nervoso all'occhio sinistro, la mascella si serrò, strinse i pugni e conficcò le unghie nel palmo della mano.
La rabbia sempre più incontenibile. «Non chiamarmi in quel modo» lo minacciò.
Ulrik acconsentì con un lieve cenno del capo, senza nemmeno degnarlo di uno sguardo. «Eva ti chiama "Dima".»
Una considerazione stupida e fuori luogo.
Ci mise un po' a comprenderla. Decise di replicare in modo provocatorio. «Sì, è un epiteto che riservo alle persone a me intime.» Calcò bene sull'ultima parola, affinché arrivasse forte e chiara.
Ma il giovane uomo non si scompose. Annuì di nuovo.
«Va bene, Adam. Non ho nessun piano. La voglio solo portare fuori da lì. Viva.»
L'Umano si sforzò di deglutire la saliva. «Cosa vorrebbe dire che non hai nessun piano? Siamo qui da ore, sta calando il sole, avevi detto che... avevi detto...»
Cos'è che aveva detto? Non lo ricordava. Forse non aveva mai detto proprio nulla.
Cosa diamine stavano aspettando?!
«Un piano richiede più strumenti, più conoscenze, più tempo. Abbiamo due armi con sedici colpi e cinque caricatori da dieci, tre pugnali, un tirapugni, un giubbotto antiproiettile e una borraccia vuota. Non so quale sia la pianta interna dell'edificio, non ho compreso quanti siano sopravvissuti all'esplosione - anche se temo siano più di una ventina -, non ho la certezza che lei sia là dentro, non posso giurare che sia ancora viva o in grado di fuggire sulle proprie gambe. Che piano dovrei ideare? Che rassicurazioni vorresti avere? La tirerò fuori, costi quel che costi. O morirò nell'intento.»
Adam soppesò cauto l'ultima promessa. Nel frattempo il comandante si rizzò in piedi.
Il ragazzino non voleva porre quella domanda, non voleva perché in cuor suo sapeva che ogni risposta che gli avrebbe fornito non gli sarebbe piaciuta, non l'avrebbe tranquillizzato affatto.
«Dinamite. Lo senti quest'odore nell'aria? Non ci posso ancora credere: mi hanno fatto trasportare sulle spalle dinamite per due settimane.» Ulrik lasciò cadere la radice ancora integra.
Sorrise. Un sorriso vero, sincero, inquietante e sereno.
Un sorriso che preannunciava l'insorgere di qualcosa di folle.
«Credi che siano stati Melchor e Solomon? Ma perché coinvolgerci? Perché non sono venuti da soli?» Il comandante storse il naso. Quell'espressione così rara sul suo volto marmoreo fu eloquente.
Adam si rispose da sé.
«Come facciamo, senza un piano, a fare irruzione e sconfiggere una ventina di uomini armati?»
Ulrik si tolse la giacca. Faceva freddo, l'aria era pungente, secca e impietosa. L'uomo roteò le spalle enormi, come se si stesse stiracchiando prima di una corsa, lo stretching prima di un allenamento.
«Hai mai visto Shani combattere?»
Un'altra domanda del tutto acontestuale. Se voleva farlo innervosire, ci stava riuscendo.
Forse era una punizione.
Adam si morse a sangue l'interno di una guancia.
Certo che l'aveva vista. Era indomita e inclemente. Ma non gliene fregava nulla. La guerriera non gli era mai piaciuta.
«Non agli allenamenti, quelli non valgono. Lì si trattiene. Un po' lo fa per me, un po' lo fa per Tomas. Anche se credo che negli ultimi tempi fosse la gravidanza a sedarla.»
Non l'aveva mai sentito parlare così a lungo. Non credeva che ne fosse capace. Di solito o rispondeva a monosillabi o con frasi frammentate che faceva cadere dal cielo.
Per l'Universo, quanto lo detestava!
«Non capisco dove tu voglia andare a parare.»
Ulrik gli porse la giacca. Adam ovviamente non l'accolse. «Shani combatte per vincere o morire. E questo è un gravissimo handicap. Non hai controllo, non hai lucidità, rischi di rimanere invischiato in una posizione scomoda, non prevedi alcuna via d'uscita, alcuna possibilità di fuga o resa.»
Spazientito, il ragazzino afferrò l'indumento.
«Ma che cazzo c'entra adesso?» lo interruppe, vedendo che si stava allontanando da solo, con indosso solo una maglia di cotone a maniche lunghe, in una direzione trasversale rispetto al bersaglio che prendevano di mira da ore.
«Ci sono altri modi per far esplodere un palazzo. Tu resta qua, ci impiegherò un'ora e mezza.»
«Ulrik!» Dima aveva un cuore arso e riarso che bruciava nel petto. «Ulrik! Non hai risposto a nessuna delle mie fottutissime domande!» gridò alla sua schiena, incurante del pericolo troppo ravvicinato. Pestò con entrambe le scarpe la giacca, gliela imbrattò di fango, sangue e titanio.
«Dove cazzo stai andando?! ULRIK!»
Ebbe la tentazione di tirare fuori un pugnale e ridurgli il giubbotto in tante minuscole striscioline sottili.
Ma non lo fece.
In un recesso del suo animo sperava che il comandante perisse e che lui ed Eva riuscissero a fuggire indenni e tornare insieme al villaggio, mano nella mano. In un altro antro, ancor più oscuro e impenetrabile, avrebbe invece voluto piacergli, avrebbe voluto la sua approvazione. E forse per questo l'odiava ancor di più, per la consapevolezza che nonostante tutto il disprezzo che nutriva nei suoi confronti, c'era anche della stima, nascosta da qualche parte.
E la voglia di essere visto, di essere considerato al suo livello.
«Spero che tu muoia» sibilò accucciandosi su una radice sporgente. Ma il suo cuore pregò il contrario.
❈
«Non c'è nessuno qui.» Kuran constatò l'ovvio.
Osservarono il punto di ritrovo, le tracce di una lotta cruenta, resti umani, macchie di titanio che assomigliavano a chiazze di petrolio sul terreno.
«Bene, torniamo indietro.» Shani scalpitava. Non aveva voluto abbandonare l'arma, ce l'aveva ancora imbracciata, i pugni serrati attorno al manico ergonomico.
«Ma che cazzo dici? Noi ce ne andiamo, ora!» Anche Tomas iniziava a sragionare, si pettinò indietro i capelli castani, si avvicinò, la guardò negli occhi e poi fece un paio di passi di lato, scuotendo la testa. «Dove sono finiti tutti?» mormorò tra sé e sé.
Senza volere il suo sguardo cadeva sempre sul ventre piatto di Shani. Ringraziò l'Universo che non vi fosse ancora alcuna rotondità, sapeva che se così fosse stato, non sarebbe riuscito a porre la sua attenzione su nient'altro.
Bea si appoggiò a un albero, pallida e tremante.
Summer aveva le lacrime agli occhi. «Devo trovare Adam.» Non si rivolse a tutti, lo disse solo a Kuran, il quale serrò le labbra sottili in una linea retta senza risponderle. «È solo un ragazzino...» cinguettò lei. Non riusciva a trattenere il pianto.
«Adam? Perché Eva?! Nessuno pensa a Eva?! Non è addestrata! Dove diamine sono finiti Solomon e Melchor?! Dov'è Ulrik?!» insistette Murphy.
«Li hanno catturati.» Bea pronunciò ad alta voce la verità che gli altri tentavano di negare a se stessi.
Shani, se possibile, rafforzò la presa sulla mitragliatrice.
«Dobbiamo tornare indietro.»
«Shani, per favore.»
«Tomas, fammi tu un favore! Datti una svegliata e tira fuori le palle!»
«Per te, dolcezza, tirerei fuori tutto l'armamentario, anche qui, davanti a tutti, ma non mi sembra il caso...»
«Ti pare il momento di scherzare?»
«Non sto scherzando, sto prendendo tempo.»
«Dobbiamo prendere una decisione» si intromise il pilota.
«Io torno indietro. »
«Tu non torni da nessuna parte.»
«Prova a fermarmi!»
«Certo, Shani! Certo che proverò a fermarti! Mi fingerò morto come un opossum, dovrai passare sul mio falso cadavere o uccidermi per davvero.»
Lei alzò gli occhia al cielo, sempre più esasperata. «Ulrik non ci avrebbe abbandonati.»
«Solo a lui pensi? E Adam? Ed Eva? Non eravate amiche?» strillò Summer con gli occhi sempre più lucidi e angosciati.
«Ulrik salverà Adam ed Eva! È l'unico che può farlo! Mi sembra così ovvio. Troviamo lui, risolviamo questa situazione di merda e ce ne torniamo al villaggio.»
«Shani...» Tomas si stropicciò il viso con entrambe le mani. «Perché fingi di non voler capire?»
«Non abbiamo un comandante.» Lo squittio di Bea arrivò distante. Si voltarono tutti nella sua direzione. Era madida di sudore freddo, distesa a gambe divaricate contro un faggio.
«Priorità, ragazzi!» sbuffò l'ex-terrorista.
«No, ha ragione, invece.» Kuran la fissò pensieroso. «In questo modo non riusciamo a decidere. Ognuno di noi ha dei vincoli personali, dei legami. Se fosse per me trascinerei Summer al villaggio, vi abbandonerei qua seduta stante. Ma non lo faccio. Questo perché sono ancora un membro di una spedizione, perché ho degli obblighi da rispettare. Qualcuno di noi deve decidere come procedere, qualcuno di noi deve assumersi la responsabilità delle azioni di tutti quanti.»
La sua ragazza era arrossita, aveva socchiuso le labbra per ribattere, poi le aveva richiuse. Si era scambiata un cenno d'intesa con Tomas. Aveva ragione Kuran, non erano abituati alla democrazia, tantomeno alla collaborazione.
Il comandante dell'arca K-030 aveva provato a insegnare loro che l'emotività era un abbaglio, che dovevano affrontare i propri limiti, sfidare le energie represse, assumere il controllo anche nelle situazioni scomode.
Ulrik avrebbe voluto che fossero una squadra, un branco unito, compatto, solidale.
Non lo erano, aveva fallito.
E loro insieme a lui: erano la prova vivente del suo personale fallimento.
La stessa riflessione fu condivisa da tutti e cinque superstiti, perché tutti avevano partecipato agli allenamenti mattutini, perché tutti avevano sbuffato quando Rik ripeteva sempre le stesse frasi, quegli inutili e tediosi "fondamentali". Qualcuno si era pure addormentato, qualcun altro aveva diretto la mente altrove, in un mondo di fantasticherie.
«Bè, il più vecchio sei tu.» Murphy si rivolse a Kuran, che inarcò contrariato un sopracciglio.
«Non ho alcuna propensione al comando. Shani avrebbe dovuto essere la vicecomandante. In assenza di Hans, sarà lei ad assumere il suo legittimo ruolo.»
La guerriera si irrigidì, lasciò cadere le braccia lungo i fianchi, inebetita.
Eppure non ci furono repliche, nessuna obiezione. Non ci fu nemmeno bisogno di votare, anche se comunque quella non era un'abitudine tra i figli dell'Accademia.
Tomas chinò il capo, Summer invece puntò le sue iridi verdi come fari abbaglianti contro di lei.
«Quindi?»
La ragazza emise un sospiro stanco.
Responsabilità voleva dire accettare ogni conseguenza provocata dal proprio comportamento. Responsabilità voleva dire essere chiamata a rispondere di eventuali danni, errori, violazioni colpose o dolose di leggi o dogmi etici e morali.
Responsabilità voleva dire che non poteva permettere che fosse il suo cuore in fiamme a decidere, non poteva permettere che la sua avventatezza li conducesse al rogo.
«Spostiamoci da qua, raggiungiamo una zona sopraelevata e studiamo dall'alto la situazione. Aspettiamo. Se entro domani non avvistiamo nessuno, facciamo ritorno al villaggio, prima che sia troppo tardi.»
❈
Evangeline Kotova, diciassette anni, un metro e sessanta d'altezza, quarantacinque chili scarsi.
Le avevano acconciato i capelli in un'elaborata treccia alla francese che partiva dalla nuca. Il laccio di plastica rosa con due perline bianche rimbalzò sulla sua schiena quando scosse il capo. Le avevano spuntato le punte rovinate e messo dell'olio sulle lunghezze per rendere la chioma più luminosa.
La doccia non era riuscita a sciacquare via ematomi e graffi. Così l'avevano truccata con cosmetici scaduti e polveri di derivazione naturale. L'arto mutilato era stato fasciato fino al gomito. Una precauzione ridicola. Ma Eva non aveva riso.
Scrutava quella ragazzina allo specchio, l'abito azzurro con la scollatura a cuore, le spalline di chiffon, i punti luce intessuti nel corpetto aderente.
Il colore dei suoi occhi.
Si erano impegnati per renderla presentabile. E questo era un pessimo segno.
Eva chinò il capo dall'altro lato e la treccia ricadde su una spalla, bionda, lucida e corposa.
«Sei pronta? Vuoi usare il bagno?» Sofia attendeva dietro la sua schiena, appoggiata alla porta aperta.
Non si poteva chiamare "bagno" quel luogo incrostato e desolante, con uno specchio rotto, una doccia scoperta, un buco nel pavimento che fungeva da turca e un lavandino sbeccato.
Evangeline le sorrise riconoscente. «No, grazie. Sono pronta.»
Anche Sofia abbozzò una specie di ghigno, ma deviò lo sguardo altrove.
"Meglio così" pensò l'Umana. "Molto meglio così."
Ammiccò al suo riflesso, come se dall'altra parte di quel portale immaginario ci fosse qualcuno che potesse vederla.
«Dima sarebbe fiero di me.» Credeva di essersi pronunciata a mente; invece, si era espressa ad alta voce. O quasi.
«Hai detto qualcosa?» Sofia corrugò la fronte. Aveva inteso solo l'ultima parte: fiera di me.
La ragazzina scosse il capo, la raggiunse ubbidiente.
Non aveva bisogno di manette, corde, lacci o guinzagli. Si era mostrata docile e mansueta. L'avevano rinominata gattina.
"Graffia solo se necessario, non capisce nulla, non sa parlare, ogni tanto qualcuno l'ha sentita miagolare. Loro si divertiranno a giocare con lei, si divertiranno un mondo! Ovviamente avrà vita breve, ma cosa importa? Gli Antichi compravano di sovente animali domestici per rinchiuderli dentro le loro abitazioni. Quando morivano, preparavano urne colorate con patetici epitaffi in corsivo, li bruciavano nel camino e conservavano sulle mensole in soggiorno le loro ceneri, prigioniere in eterno di quelle quattro mura. Un tempo gli animaletti erano una proprietà, come la televisione, l'asse da stiro, le posate d'argento ereditate dai bis-nonni o un bel quadro da appendere in camera da letto. Loro ragionano ancora così. Lei adesso è di loro proprietà."
Evangeline li aveva uditi e ne era rimasta affascinata. Aveva finto di non comprendere, ovvio.
"Sorprendimi" le ripeteva spesso l'Umano durante l'allenamento.
Sì, Dima sarebbe stato fiero di lei.
E poi comunque presto o tardi sarebbe tutto finito.
Avrebbe chiuso gli occhi e sarebbe tornata da lui.
Sarebbe stato tutto solo un incubo orribile. Sarebbe stata al sicuro. Tra le sue braccia muscolose, al caldo, a respirare per sempre quel profumo unico al mondo, che non aveva eguali.
E gli avrebbe chiesto scusa, avrebbe pronunciato quelle due paroline che non aveva mai avuto l'ardire di confessare. E l'avrebbe stretto a sé fino a farsi male. E avrebbe pianto e riso per il sollievo. E sarebbero stati felici. Come in un bel sogno.
Come in paradiso.

In questo capitolo abbiamo solo domande. Tutte senza risposta, obviously.
Qual è il piano di Ulrik? Dove è andato? Tornerà?
Qual è il destino di Eva? Cosa vogliono da lei? Cosa sta pianificando?
Che sorte toccherà al resto della squadra? Riusciranno a ricongiungersi?
Questa la pacata reazione di Adam ai quesiti senza risposta:
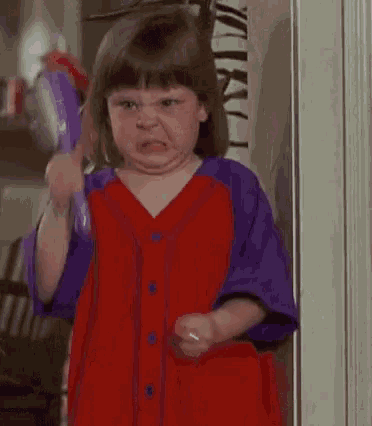
Io vado a rispondere ai commenti dello scorso capitolo 👀
Scusate, ma in questo periodo perdo pezzi 🙈
Considerate che dietro questo schermo c'è una persona in carne e ossa, con un lavoro a tempo pieno, problemi vari, una famiglia... come tutti! (n.d.r. c'è stato un commento poco carino, io non ho detto nulla, ma ha fatto molto male).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro