20. Angelo d'inchiostro

Angelo d'inchiostro
N.B musicale: preferibilissima ascoltare Touch dei Sleeping At Last nel momento in cui, nella terza parte, Desmond si alza dal divano. Ci vediamo giù! 🕊️
"È una cosa tua. Tu la rompi e tu la aggiusti."
Avevo smesso di contare il numero di volte che quella frase mi si era riproposta in testa, come se qualcuno si fosse sporto oltre la porta del timpano e, con le mani ai lati della bocca, l'avesse gridata, lasciando che un'eco immortale si diffondesse nella grotta che era la scatola cranica. L'eco, inizialmente lieve, giorno dopo giorno aveva cominciato a nutrirsi del proprio significato, di ciò che avrebbe implicato in termini di azioni, e di volta in volta non aveva fatto che crescere, diventando più ingombrante, un serpente che si nutriva della propria coda.
Una coda che, però, non finiva mai.
Non ero riuscita a ignorarlo.
L'apatia di quella domenica, intanto che le foglie creavano bizzarre e sfarfallanti piogge purpuree e il fracasso di un tosaerba ronzava nel giardino del vicino, mi aveva permesso di generare un pensiero. Un esperimento, in realtà. Rischioso, avrei aggiunto. E proprio per il rischio che avrebbe implicato alla mia dignità, era necessario che lo facessi da sola, mentre i miei genitori si erano assentati per partecipare al festival autunnale della città di Ellicott, e per cui avevo rifiutato l'invito. Preferivo approfittare di avere casa libera per seguire il mio piano, piuttosto che salire su una seggiovia per fotografare lo spettacolo a colori che creava l'autunno.
Per quanto mi fosse dispiaciuto, la priorità era un'altra.
Nonostante tentennassi ancora all'idea, avevo posizionato una sedia davanti allo specchio di camera mia e mi ci ero accomodata. Da dieci minuti non facevo che guardarmi. Il nervosismo mi obbligava a sfregare i polpastrelli sul contorno incurvato delle unghie, ignorando il fastidio a ogni insistente passata.
"Tu la rompi e tu la aggiusti."
Abbassai lo sguardo sulle dita e, storcendo il naso, notai come si fossero rovinate ai lati delle unghie. Pelle arrossata, in certi punti scorticata, e del sangue rappreso dichiarava che quello stato d'animo, di recente, si fosse trovato al centro della mia quotidianità. I picchi d'ansia erano cani randagi allergici al guinzaglio, e non ero mai stata capace di addomesticarli, placarli.
"Tu la rompi."
Il cellulare, in carica sul letto, aveva lo schermo acceso sul video che avevo interrotto qualche istante prima, uno di quelli presenti sul canale YouTube Out Loud. Non era mai stato eliminato definitivamente. Warren, all'epoca, ne aveva oscurato i contenuti solo in maniera temporanea, così che la gente che passava da quelle parti non potesse né vedere, né commentare.
Se da un lato non sopportavo l'idea che non avesse cancellato tutto in modo permanente, estirpando ogni ricordo alla radice per aiutarmi a dimenticare, dall'altro era meglio così: nei momenti meno allegri rivedere quei video era un toccasana per la malinconia.
"E tu la aggiusti."
Deglutii.
Allo specchio, mi fissai la gola. Ne accarezzai la valle col palmo, su e giù, destra e sinistra. Infine, mi fermai e ci bussai con due dita. Mi sento così stupida a volerlo fare. Mi girai verso la porta aperta, tendendo l'orecchio per qualche secondo e scongiurando che mia sorella, intanto, non fosse tornata dall'uscita con le sue colleghe.
L'attenzione scivolò di nuovo sullo specchio.
Tanto non cambierà niente, tanto non aggiusti un cavolo.
Trassi un bel respiro e, col cuore che minacciava di scoppiare, poiché era impreparato quanto me, alzai un braccio, anche se di poco. Uno, due, tre. E iniziai a schioccare le dita.
Continuai, alternando respiri profondi ai rintocchi. A ogni schiocco, un respiro. Era un rituale che io e Jay attuavamo sempre a casa sua, prima che mi aiutasse a esercitarmi nell'estensione canora.
Cambiai, alternando gli schiocchi a dei colpi sulla coscia.
A quel punto, senza smettere di farlo, scrutai le labbra schiudersi nello specchio e lasciai che uscisse la flebile introduzione della canzone Bird Song.
«Well, I didn't tell anyone, but a bird flew by
Saw what I'd done he set up a nest outside,
And he sang about what I'd become.»
Quel preludio non conteneva alcuna alterazione melodica eccezionale; si trattava perlopiù di un monologo intimo, in questo caso un tête-à-tête col mio riflesso. Nel farlo mi studiavo, rispolveravo tasselli del mio io a cui non davo più la dovuta importanza. Così, quella prova di canto accompagnò il tentativo di rivedermi, esaminando attentamente i contorni degli occhi, la punta del naso, le sopracciglia folte, il piccolo neo sullo zigomo simile a un chicco di caffè.
Ophelia è sempre lì. Ophelia è sempre Ophelia.
Anche se è sempre un po' rotta e confusa e incapace.
Anche se l'Ophelia rotta è tanto stanca di sentirsi così rotta.
Aggrappandomi al testo di Florence and the Machine e continuando ad alternare schiocchi e colpi sulla coscia, decisi di chiudere gli occhi, la lingua che accarezzava ogni parola gli proponessi. Mi resi conto che, a differenza di quando avevo azzardato a cantare dagli Holmberg, avvertivo molta meno ruggine a frenare gli ingranaggi che mulinavano tra le corde vocali.
«But he sang louder and louder inside the house,
And no I couldn't get him out
So I trapped him under a cardboard box
Stood on it to make him stop.»
Appena il monologo si trasformò in una guerra dalla cadenza svelta, mi spuntò un sorriso. Cantai sorridendo. Cantai riaprendo gli occhi, interfacciandomi con la realtà. Cantai guardandomi, facendo conoscenza con un'altra Ophelia, una nuova, una che stava sperimentando, che avrebbe desiderato riappropriarsi della sua seconda casa. Forse non è così impossibile provare a riparare i danni.
Però, c'era da mettere in conto anche un'altra cosa: il canto, dopo mesi di letargo, aveva alterato la voce, l'aveva ridotta in frantumi, e così il testo si trovava ostacolato dalle mie insicurezze, metaforicamente dei pezzi di vetro che ferivano, rovinavano il risultato ancor prima che uscisse dalla bocca. Perché magari una nota usciva troppo potente, troppo singhiozzata, troppo lenta, acuta, frettolosa. E far fluire dei versi melodici era un supplizio, un terribile raschiare in gola.
«I picked up the bird and above the din I said.»
Era probabile che stessi addirittura stonando.
«That's the last song you'll ever sing.»
Però non volevo smettere, non ora che mi sembrava di volare.
«Held him down, broke his neck.»
O magari non stavo eseguendo le intonazioni corrette.
«Taught him a lesson he wouldn't forget.»
Non importava, era così bello tornare a respirare.
«Cosa stai facendo?»
Scattai in piedi, rischiando di far rovesciare la sedia. Il sorriso si spense, la canzone sbiadì nel vuoto, l'emozione si sgonfiò. Mi dovetti aggrappare allo schienale per non cadere; le gambe si erano improvvisamente rammollite appena mi era giunta la voce di Olivia.
Lei si era congelata sulla soglia come una guardia. Il cappotto aperto che sfumava dal nero al grigio le scivolava fino alle ginocchia, la borsa di Michael Kors le oscillava sotto al gomito. Io, quell'espressione, non glielo avevo mai vista. Non riuscivo a inquadrare a cosa stesse pensando, o perché, affacciandosi in camera, quasi si stesse accertando di non essere capitata in tutt'altra casa, apparisse così smarrita e nervosa e perplessa. Su quel volto curato e perfetto, al momento c'era un disastro di stati d'animo, e non facevano che oscillare e oscillare.
Inspiegabilmente, mi sentii la gola arida.
«No, niente, stavo solo... Cioè, lo specchio, stavo...»
Non mi aveva ancora guardata; si introdusse nella stanza al pari di una sconosciuta, fissando il telefono sul letto, rimasto acceso. Senza pensare, mi fiondai a staccarlo dal caricabatterie e a inserirlo in tasca prima che capisse cosa stessi facendo. Solo allora alzò lo sguardo.
«Quando sono entrata ho sentito qualcosa.»
«Musica. Spotify. Dal telefono.»
Perché le sto mentendo?
«Stavi cantando.»
Strofinai la lingua sull'arcata dei denti, percependo il cuore impedirmi di rimanere calma, di intrattenere una conversazione normale, che tanto, anche se avesse capito cosa stessi facendo, in fondo non sarebbe accaduto nulla di male. Era pur sempre mia sorella. Perché avrei dovuto nasconderglielo? Era dai miei genitori che mi nascondevo. Perché avrei dovuto farlo con lei?
Deglutii, fissandole gli stivali. «E se per... ipotesi fosse così?»
I tacchi risuonarono sul pavimento come un inno battagliero mentre si aggirava nella camera. Non alzai il viso. Poi la scorsi sedersi e accavallare le gambe. «Stavi cantando, allora.»
Afferrai il gomito dell'altro braccio, e grattai, grattai.
«Non era niente. Una sciocchezza.»
«Una sciocchezza, ma la stavi facendo.»
«Era...» Umettai le labbra secche. «Era solo un esperimento.»
Trasse un sospiro dalle narici, gli occhi chiusi, posando una mano a lato del collo. Lo tese a destra e poi a sinistra, fino a farne scrocchiare le ossa. «Mi fa piacere che tu stia sperimentando, Ophelia, è un gran passo avanti dopo tutto questo tempo. Però devo essere sincera.» Se una microscopica parte di me era sicura che confessarglielo fosse corretto, che magari, com'era accaduto con Desmond, avrei trovato uno sprono a provarci di nuovo, ora le mie convinzioni barcollarono, si fecero piccole piccole davanti a uno sguardo colmo di rimprovero, colmo di freddo, di nulla. Olivia inclinò il volto sulla spalla. «È meglio che tu non lo faccia.»
Premetti le labbra, mormorando: «Cosa?»
Si issò in piedi, mi racchiuse il volto tra le mani e mi rivolse un'occhiata compassionevole, i pollici che sfregavano le gote con dolcezza. «Dopo quell'incidente, sorellina, eri ridotta molto male... Mi si spezzerebbe il cuore se dovessi passare un altro periodo nero.»
«Ma se ci riprovassi? Se lo facessi solo qui, in casa, se...»
«Riflettici: se lo facessi, faresti sentire tremendamente in colpa mamma e papà. Sentirti cantare di nuovo, come ai vecchi tempi, gli ricorderebbe che razza di bugiardi sono stati nei tuoi confronti. Il loro è stato un atto tanto meschino che, onesta, mi fa tutt'ora schifo.»
Lo stomaco si annodò, mi venne da vomitare, e avvertii un denso groppo di lacrime che, prepotente, stava risalendo su, su, sempre più su, mentre le fissavo le labbra rosee. «Ma se...»
«Fidati di me, sorellina, è meglio così: lascia stare.»
Mi diede un bacio sulla fronte e fece per uscire. Fissando il pavimento, non seppi come, ebbi il coraggio di chiederle: «E a te?» I tacchi sostarono sulla soglia, lei rimase di schiena. «A te sono... piaciuta? Quello che hai sentito prima, secondo te andava bene?»
Mi sentii infantile a farle una domanda simile. E nel porla, strinsi le mani a pugno, sfogai il nervosismo e l'impulso di scoppiare a piangere conficcando le unghie nella carne. Tuttavia, l'inconscio mi suggerì che sarei sopravvissuta anche senza conoscere la risposta.
Fai ancora in tempo a dirle di lasciare perdere.
I secondi passavano. E io non mi sentivo più le gambe.
Finalmente Olivia si voltò, esibendo un sorriso tiepido, dove, per un attimo, ci colsi la più infima delle speranze. «Mi dispiace. Non mi sento di essere ipocrita come mamma e papà, Ophelia. Con te sono e sarò sempre sincera, lo sai.» I suoi occhi slittarono placidamente dalle mie spalle ai miei piedi, e lì si soffermarono. Sembrò costarle una fatica immensa dover pronunciare ciò che ne sarebbe seguito. «A me non sei piaciuta. In realtà, ti ho sempre trovata abbastanza stonata. Ma non prenderla sul personale, si tratta perlopiù di un parere soggettivo.»
Stonata.
Guasta.
Rovinata.
«Capito.» Finsi disinvoltura, concentrandomi sulle crepe al muro che avevano bisogno di una stuccata, anziché su quelle che si erano aperte nel cuore. Mi schiarii la gola, sperando che non si avvertisse il tremolio, sebbene gli occhi bruciassero tanto. «Non so più cantare.»
«Ammesso che sapessi farlo anche prima.»
Un sorriso amaro e sparì nel corridoio.
Dal rumore della porta accanto che si chiudeva capii che non era andata in bagno. Non seppi per quanto tempo rimasi a fissare le crepe all'angolo del muro che si diramavano come sottili ragnatele, ma proprio come se lo fossero, riuscirono a tenerci incollati i miei occhi, che si erano ridotti a due conche colme di lacrime.
Solo quando sentii lo scrosciare della doccia introdursi nel silenzio che si era creato, mi imposi di distogliere lo sguardo dal muro. Non piansi, e i palmi bruciavano per essere l'oggetto di uno sfogo così violento. Ma mi trattenni. Ero stanca di rendermi ridicola. Perché tanto ha ragione, non merito nemmeno di restarci così male. Per cui, feci ciò che era meglio per me e per chi mi circondava: smettere di sperimentare cose che non sarebbero tornate come prima.
La sedia tornò al suo posto.
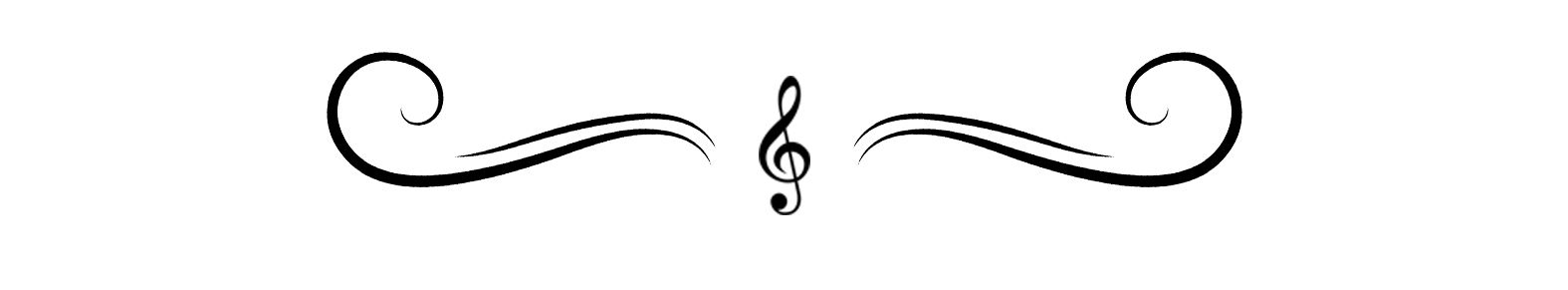
Qualcosa si spense.
Le parole di mia sorella si erano insinuate nella carne e avevano premuto un interruttore che nascondevo dagli occhi della gente, preservato dai nervi e dal cuore.
Era questione di tempo perché mi fronteggiassi con la cruda realtà. Per qualche insensata ragione stavo cercando di temporeggiare fino al giorno in cui avrei capito che, in gola, era tutto irreparabile. Forse, come supponeva Olivia stessa, lo era sempre stato, sin dagli arbori. Forse ero l'unica a non essermene mai resa conto. Forse, per tutto questo tempo, avevo davvero suscitato compassione nei miei genitori. E forse, sì, mi avevano solo mentito.
Così, con uno schiocco di dita, mi ero ritrovata al buio, e quel poco di luce rimasto a ravvivare le mie speranze si era estinto. Con le lacrime perennemente sull'orlo del precipizio, evitavo di specchiarmi, curarmi, studiarmi. Non voglio più guardare il volto del fallimento. Evitavo gli sguardi dei miei genitori. Non voglio più farvi pietà. E avevo deciso che fosse meglio parlare meno. Perché non avrei dovuto attaccarmi tanto all'importanza della voce.
Mi ero ritrovata a trattenere.
«Ophelia, tesoro.» Papà, una sera, si era affacciato in cucina mentre stavo riempiendo il lavello con acqua e detersivo. Non mi ero girata; avevo continuato a fissare le montagne di schiuma crescere. «Sono pochi piatti, non era necessario questa volta... C'era la lavastoviglie.»
«Lo so.»
Si era appoggiato al bancone da lavoro. Io, per non essere obbligata ad affrontare il suo sguardo, avevo afferrato la spugna accanto al rubinetto e avevo iniziato a strofinare le posate.
«Ascolta.»
Avrei voluto non continuasse, perché avevo intuito dove avrebbe voluto andare a parare con quella premessa. Per sopportare meglio l'attesa, avevo strofinato forte, con un'aggressività tanto inaudita che avevo temuto di piegare la lama dei coltelli o di frantumare i bicchieri.
Aveva sentito la sua mano posarsi sulla schiena.
E io avevo trattenuto, gettando le posate lavabo vuoto.
«È da un po' che non facciamo quattro chiacchiere, vero?» Avevo afferrato tre cucchiaini. «Io e tua madre l'abbiamo notato già da qualche tempo. In realtà, volevo aspettare prima di prendere questa conversazione, ma abbiamo paura che tu ci stia evitando per...» Si era schiarito la voce, forse per paura di sembrare inopportuno. «C'è qualcosa che ti turba? Sei diventata così spenta che...»
«Sto bene.»
E avevo trattenuto ancora, pressando la lingua sul canino.
«No, tesoro, non dirlo» aveva mormorato, mentre si toglieva gli occhiali e gli dava una lucidata aiutandosi con la maglietta del pigiama. «A malapena ci parli, se proviamo a parlarti ci eviti, e...» Aveva inforcato gli occhiali, io avevo continuato a sfregare i piatti. «Ci manchi, Ophelia, tanto. Torni da lavoro e ti rinchiudi in camera, con tua sorella non c'è dialogo, e quando sei a casa è come se non ci fossi, come se non volessi farti sentire da noi, e ci fa molto male.»
Mi ero fermata dal lavare le stoviglie, fissando la schiuma.
E avevo trattenuto di nuovo, la spugna stretta tra le dita.
"Gli ricorderebbe che razza di bugiardi sono stati."
Papà si era accorto che non avrebbe ricevuto nient'altro che il silenzio; per cui, comprendendo che era meglio non insistere, mi aveva dato due carezze alla schiena per poi allontanare la mano.
«Ehi» mi aveva chiamata, piano.
Lentamente, mi ero sforzata di girare la testa, lo sguardo sempre basso. Se l'avessi alzato avevo i miei dubbi che non sarei scoppiata a piangere.
Ciò che avevo ricevuto aveva messo a repentaglio la mia prova di resistenza. Perché papà mi aveva inferto due colpetti sulla gola, con due dita. Me ne ero sorpresa a tal punto da sollevare gli occhi sulle sue labbra, e non oltre. Aveva stampato un sorriso dal retrogusto amaro.
Era il nostro modo per dire: quando te la senti, non c'è fretta.
«Ok?»
Avevo annuito, in silenzio, lì pronta a crollare.
Tuttavia, nel trattenere avevo percepito quanto ne avesse risentito la salute. Nei giorni a seguire avevo alternato dei mal di testa che mi avevano costretta a non chiudere occhio, a momenti in cui la debolezza mi afferrava sia muscoli che le sinapsi, fino a rendermi fiacca, poco lucida, meno attenta. Senza contare che, con il nervoso che mi mordeva lo stomaco e le forze che impiegavo per trattenere il pianto sempre più al culmine, mangiavo la metà. Mi aveva solleticato l'idea di darmi malata dal babysitting, solo per qualche pomeriggio, per avere la possibilità di riprendermi. Ma poi finivo sempre per accantonare quel pensiero stupido, sapendo che gli Holmberg non avrebbero mai potuto badare ai bambini, specie se lo zio lavorava.
Mi ero impasticcata di aspirine, sperando mi aiutassero.
Ma ora, accomodata alla scrivania dei bambini, avevo capito che non servivano a niente. Il mal di testa, seppur più sopportabile, si faceva sentire a ritmi alterni, bussando alle tempie con la violenza di un gong, e la spossatezza aveva raggiunto picchi in cui, anche per alzarmi da una sedia, pareva mi gravassero degli zaini colmi di pietre sulla schiena e sulle gambe.
Per sicurezza, avevo chiesto ai ragazzi di non starmi vicina.
Avevano eseguito, seppur straniti dalla richiesta.
Avevo impiegato il tempo che mi separava dall'arrivo di Desmond a fissare i disegni di Cindy e ad ascoltare le canzoni che mi proponeva Leonard col suo MP3. In entrambi i casi, non riuscivo a mostrare più di un sorriso flebile. Non avevo entusiasmo. Non avevo niente. Tutto rotto, luce spenta, interruttore guasto, voce in gabbia.
Dovrò tornare a casa.
Sfregai le unghie sul foglio con disegnata una ragazzina.
Dovrò tornare a casa...
«Ophelia.»
Cindy si era seduta alla scrivania. Incrociò le braccia sul tavolo e ci posò il mento. Dall'espressione sospettosa, capii che stava per fare una delle sue solite domande a bruciapelo.
«Ehi, dimmi.»
«Perché parli poco?»
Sorrisi. «Sono un po' stanca.»
Con un cipiglio a indurirle lo sguardo, sollevò il mento e prese uno dei suoi disegni, senza osservarli sul serio. «Sei di nuovo triste?»
Mi piacerebbe non esserlo più, Cindy.
«Solo giù di corda, tutto qui.»
«Ok.»
Scrollò le spalle e aggregò i fogli in una pila. Mi chiesi se fosse dovuto al fatto che finalmente stesse a sentire di più suo fratello, ma sembrava avesse assimilato parte del suo carattere. Era meno indiscreta di prima, cosa che apprezzavo: stava imparando a rispettare i limiti degli altri.
Lisciò i fogli e si rivolse a me, inarcando un sopracciglio.
«Posso farti una domanda, anche se sei giù?»
«Ma certo, non farti problemi.»
Congiunse le labbra, rendendole strette strette, segno che stava considerando se porre la domanda. Poi sostenne la guancia con la mano, chiedendo: «A te piace zio Des?»
Sollevai le sopracciglia, improvvisamente più sveglia.
«Come, scusa?»
«Boh, ti ho vista tenergli la mano.»
Battei le palpebre, perplessa. «Aspetta, quando?»
«L'altra volta. Mi ero svegliata e vi ho visti dalle scale. Vi stavate tenendo per mano.» Riflettei che si stava riferendo a quando Desmond era rientrato con la febbre alta. «Allora? Ti piace o no?»
«No! Cioè... tenersi la mano non vuol dire nulla.»
«Lo fanno i fidanzati, vuol dire che si amano.»
«Lo fanno anche due amici, o due fratelli.»
«Io non tengo la mano a Leonard.»
«Sì c-che l'hai fa-fatto!» s'intromise quest'ultimo, mentre costruiva una casa coi Lego. «Qua-quando papà era in o-ospedale.»
«Perché sei un fifone e senza di me te la saresti fatta addosso.»
Leonard si voltò, punto sul vivo, e le fece la linguaccia.
Lei roteò gli occhi. «Vabbè. Quindi non ti piace?»
«Ma no, è solo una persona che stimo tanto, lo trovo gentile, simpatico.» Nonostante l'umore sotto terra, quella supposizione mi fece sinceramente sorridere. «E poi è troppo grande per me, Cindy.»
«Mah, secondo me non siete così diversi, e poi tu piaci a zio Des, ti vuole bene, si vede da come ti parla.» Prese un pastello nero e rimarcò i contorni della ragazza dai boccoli biondi. «Ah, e mi stai più simpatica di zia Latisha. Lei quando stava con noi non si divertiva.»
È un modo strano per dire che ho la tua benedizione?
Mi allungai per poterle accarezzare i capelli crespi, lasciando che si divertisse un altro po' con quelle assurde ipotesi. Tuttavia, non bastò per distrarmi dal punto focale dei miei pensieri: dover tornare a casa, affrontare le occhiate apprensive di mamma e papà, sopravvivere un altro giorno da illusa, in quattro mura che cominciavano a starmi strette, che ogni giorno iniziavano a prendere le forme delle fredde inferriate di una gabbia. Non ce la faccio più.
Un allegro motivetto fischiettato seguì la porta chiudersi.
Strofinai i polpastrelli sul foglio, il cuore palpitò forte. Non di già.
Desmond varcò la soglia con in mano una ventiquattr'ore, tutto pimpante, esordendo con un raggiante: «Buonasera, mostri».
«Io non sono un mostro» si difese Cindy. «Leo sì.»
Leonard la spintonò. «Io so-sono bello, st-strega.»
«Facciamo che siete brutti entrambi, così evitiamo inutili favoritismi. Ma comunque, ho un urgente bisogno del vostro aiuto.»
Sbloccò la valigetta e tirò fuori alcuni moduli che tenne tra le labbra, mentre con una mano frugava. Riuscì a trovare ciò che cercava, i bambini rimasero in attesa, cercando di mettersi sulle punte e capire cosa stesse facendo. Alla fine lo zio si inginocchiò davanti a loro, si tolse i moduli dalla bocca per riporli al loro posto e gli mostrò invece un paio di fogli, ciascuno in una mano.
«Sondaggio: quale dei due disegni vi piace di più? Mi raccomando, scegliete responsabilmente, perché la vostra decisione segnerà le sorti del progetto.»
Rimasi alla scrivania, incapace di muovermi, timorosa di alzarmi, salutarli, andarmene. Preferii procrastinare, fissando un punto vuoto alle loro spalle, poi il pavimento. Cindy e Leonard, nello stesso momento, puntarono un disegno: la prima a destra, il secondo a sinistra. Una parità.
Desmond inarcò un sopracciglio. «Sul serio?»
Scrollarono le spalle.
«Va bene, allora qual è quello disegnato meglio?»
Alternarono la scelta: Cindy puntò a sinistra, Leonard a destra.
«Non ho parole. Io conto su di voi e voi mi mettete più in difficoltà di prima. D'accordo, allora...» Qualche istante di silenzio, che impiegai a fissare il pavimento. «Visto che vi siete rivelati inutili, risolviamo il pareggio chiedendolo alla babysitter.»
Tempo niente che il campo visivo venne occupato da lui, chino sui talloni. Sussultai, tanto ero concentrata sulle fughe del pavimento.
«Ti va di fare il giudice di un esperimento didattico?»
Con la lingua impastata, mi limitai ad annuire.
Mi mostrò i disegni a matita che immaginavo avesse abbozzato lui stesso. «Aquila o pavone? Non fare domande, rispondi e basta.»
Presi in mano i fogli, studiandoli attentamente, nonostante non fossi per nulla concentrata. I due animali erano stati disegnati nei minimi particolari, sbiadendo in direzione delle zampe. Parevano fotografie in bianco e nero. L'aquila potrebbe portarmi lontano da qui. Gli occhi slittarono sull'altro contendente. Il pavone è così sicuro di sé, così fiero, un'anima colorata. Mi focalizzai su quella schiera di piume che si prolungava ad arcata dietro il collo lungo.
Mi ricordò l'indole di mia sorella.
Mi ricordò le sue parole fredde, dure.
Mi ricordò l'angoscia che provavo quando la guardavo, perché non sembrava neanche più l'Olivia che avevo conosciuto, la ragazzina dall'abbraccio facile, dal sorriso spontaneo, dalle risate dovute alle battute stupide di papà. Ora evitava qualsiasi contatto fisico, dosava i sorrisi, le uniche occasioni in cui ci fermavamo a parlare era per questo. Per farmi presente cosa fossi: un guscio vuoto, rotto, uscito male, senza voce, con un'esistenza basata su dei cocci.
Una volta avevi detto che la mia voce ti piaceva... Cos'è cambiato, Liv? Cos'ho sbagliato? Quando ho iniziato a sbagliare? O forse sto sbagliando da tutta la vita, ancor prima di venir concepita?
"Ammesso che sapessi farlo anche prima."
Una minuscola sfera colpì la carta e si allargò come una macchia di inchiostro nel punto in cui c'era la testa del pavone. La confusione mi fece battere le palpebre, e le pozze diventarono due, tre, quattro.
A fiato corto e con dei balbettii arrotolati sulla lingua, non feci in tempo a realizzare cosa stesse accadendo che Desmond mi sfilò i fogli di mano, recuperò rapidamente un astuccio coi pastelli dal tavolo e raggiunse subito i suoi nipoti, spalancandogli la porta.
Gli lanciò due fischi e un cenno verso il corridoio.
«Me li colorate in salone?»
«Ma perché la babysitter sta...»
La voce allarmata di Cindy venne bloccata.
«Dopo. Ora coloratemi bene questi.»
Sgambettarono via, Desmond chiuse la porta, e io mi coprii la faccia con entrambe le mani, sostenendo i gomiti sulle ginocchia. Si riversò tutto ciò che avevo trattenuto per giorni, senza che potessi comandarlo. In silenzio e mordendomi con insistenza le labbra, cercai di ricacciare indietro quello sfogo, ma nulla da fare, a quanto pare era più stanco di me. Non riuscii nemmeno a placare le spalle scosse dai singulti. I palmi continuarono a schiacciare gli occhi, ingenuamente sperando di frenare la valvola che mi avrebbe impedito di gettare le lacrime.
«Ophelia.»
«Scusa.»
«Ma che ti scusi, non hai...»
«Ho rovinato tutto... tutto quanto.»
Persi il conto di quante volte lo ripetei, non sapendo nemmeno io a cosa mi stessi riferendo. Se al disegno, se a me stessa, se alla voce, se ai miei, ai miei vecchi amici, la mia vita. Quei sussurri spezzati e sconclusionati vennero pian piano placati non appena avvertii qualcosa posarsi sul ginocchio. Togliendo di poco la copertura dal viso, vidi la mano di Desmond sopra di essa.
Era tornato chino sui talloni, come prima.
«Non hai rovinato niente, hai capito?»
«Ma il disegno si è bagnato...»
Detta così era ridicolo, ma fu l'unica frase di senso compiuto che riuscii a costruire. Non mi sorpresi se gli veniva da ridere. «Cosa, quello? Lo rifaccio in cinque minuti se a Cindy e a Leonard non va bene.» L'espressione si ricoprì di apprensione. «È successo qualcosa coi bambini?»
Negai con la testa, strofinandomi veloce le palpebre.
«Sicura? Guarda che so metterli in riga quando serve.»
«Giuro, no...» Tirai su col naso. «Loro sono perfetti.»
«E allora cosa succede?»
«Nulla, davvero, nulla, ora passa» mi affrettai, e nel dirlo le lacrime sfuggivano e dimostravano il contrario, per dispetto. «È la stanchezza, forse.»
Non insistette, ma parve non bersela. Anzi, fece di peggio: guardò ogni frammento del mio viso che ormai non riuscivo neanche più a nascondere, anche se era tutto accartocciato e scialbo e distrutto. Fissò l'attenzione su una gota, dopodiché ci posò il dorso della mano.
Esausta di pensare a qualsiasi cosa, mi abbandonai a quel tocco, esaminando il suo volto. Sebbene avessi la vista offuscata, captai lo stesso il suo sguardo mutare in uno che rasentava la rassegnazione. Tese la bocca da un lato. «Perché non mi hai detto di restare a casa?»
«Perché non ci sarebbe stato nessuno coi bambini.»
«Questo non potevi saperlo. E in caso mi organizzavo diversamente se era per un giorno, o due, dipende. Il capo redattore è mio amico e avrebbe capito, la conosce la mia situazione.» La sua mano salì su fino alla tempia. «E un po' mi sento in colpa. Non vorrei avertela trasmessa io. L'altra volta non dovevi starmi così vicina.»
Piegai la testa sulla sua mano. «È solo stress, non è niente.»
«Non so se fidarmi.» Tolse la mano, rimettendosi in piedi, e quel distacco improvviso mi fece sentire abbandonata, al freddo. «Se sei venuta in macchina te la guido io. Al ritorno prenderò un taxi.»
Fu un istinto incontrollabile, generato dal terrore.
Agganciarmi alle sue dita fu l'unica soluzione.
Rimanemmo così, per svariati istanti: io seduta, il palpitare del cuore che rimbombava persino nelle vene, nelle orecchie, e lui alzato, immobile, il braccio teso verso dove lo stavo trattenendo con l'indice. Per tutto il tempo mi focalizzai in quell'esigente legame di carne.
«Ophelia?»
Riuscii solo a mormorare un: «Non... non farmi tornare a casa».
«Cosa?»
«Non voglio...» Chiudendo gli occhi, sgattaiolò un'altra lacrima. «Non voglio, non me la sento, non oggi, ti prego... ti prego...»
«Stai scherzando?»
Strizzai le palpebre. «Rimango qui, io... Dico ai miei che Gregg ha dovuto fare la notte e sono stata costretta a rimanere coi bambini.»
«Aspetta, calmiamoci un attimo.» Sciolse la presa. «Tu non rimani nei paraggi dei bambini in questo stato, o di Gregg. Se trasmetti qualcosa a uno di loro, specie a mio fratello che non può permettersi di restare a casa, nei casini ci vai sia tu che io, va bene?»
«Non posso tornare» sussurrai, guardandolo. «Non posso...»
«Ma perché non puoi?»
«Non posso, non riesco.» Scoppiai a piangere. «Ti prego...»
Si passò una mano tra i capelli e si chiuse in un silenzio che mi rese ancor più ridicola. Non era da biasimare se mi avesse rimproverato, o qualcosa del genere; ero consapevole di aver assunto l'atteggiamento di una bambina a cui viene ricordato che è ora di scendere dalle giostre per tornare a casa. Eppure, non riuscivo proprio a concepire l'idea di varcare una soglia che avrebbe dovuto essere famigliare, farmi sentire al caldo, protetta, quando era il contrario.
Non l'avrei sopportato in quello stato, non quel giorno.
«Appena arriva Gregg prendiamo la mia macchina.»
Si allontanò senza dire altro, e io piombai nella disperazione più nera.
Alzai lo sguardo, nel panico. «Significa che poi...»
«Non torni a casa. Per oggi stai da me.» Placò qualsiasi mia risposta colma di gratitudine, puntandomi l'indice. Non era una minaccia, ma lo sembrava. «A patto che mi racconti cos'è successo.»
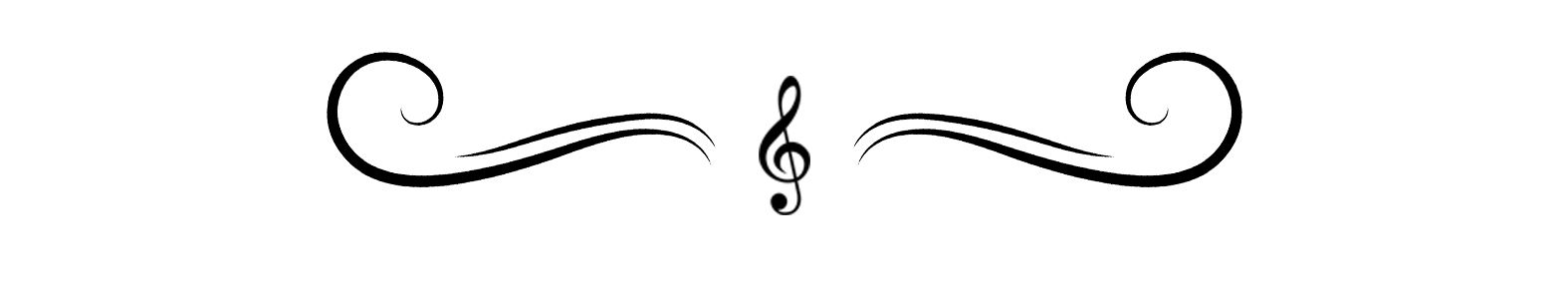
Quando Gregg aveva notato suo fratello uscire insieme a me l'aveva bloccato, domandandogli dove stesse andando, che in teoria avrebbe dovuto fermarsi a cenare. Desmond gli aveva risposto che si era permesso di ordinare da asporto per tutti loro, tranne che per se stesso, poiché preferiva rincasare per terminare un progetto urgente.
Aveva mentito.
Durante il viaggio, mentre alla radio si susseguivano fatti di cronaca ostacolati da una scarsa frequenza e i quartieri baciati dal crepuscolo scorrevano indisturbati, ero stata schiacciata dai sensi di colpa. Pur realizzando che stavamo raggiungendo casa sua, avevo preferito lasciar correre, ingoiando l'ennesima dimostrazione che ero un danno, e avevo deciso fosse meglio posare il gomito sotto al finestrino e continuare a guardare fuori, senza azzardarmi a voltarmi. Anche se per buona parte del tragitto avevo percepito le sue occhiate preoccupate addosso.
Mi ero domandata cosa avrei dovuto spiegargli, e come.
La destinazione, uno dei tanti alloggi costruiti a stampino che sbocciavano sulla Midvale Avenue, era cinta dal verde dei giardini e dei piccoli arbusti che recintavano l'area dalla residenza adiacente alla sua. Nonostante l'illuminazione fosse garantita soltanto dai lampioni sfarfallanti sul marciapiede, o dalle lucine sferiche collocate ai piedi delle siepi, si poteva notare come le sfumature scarlatte e brune delle foglie cadute andassero a contrastare il colore dell'erba.
Sulla soglia, Desmond premette l'interruttore della luce.
«Perdonami. Non ero preparato a delle visite.»
Mi strinsi nel giubbotto, la pelle d'oca che serpeggiava sulla pelle, e mi mossi in quell'ambiente nuovo, un po' in imbarazzo per averlo praticamente costretto a ospitarmi e un po' impressionata dalla quantità di disordine che regnava su ogni piano distinguibile. Pile di fogli, perlopiù, ma anche fascicoli, portfolio, documenti di vario genere. Imperavano il tavolino dinanzi al divano, le poltrone che lo circondavano, i lati del televisore, collocato a sua volta su un mobiletto.
Non mi aspettavo che avesse un modo di vivere così caotico.
«Tranquillo, va più che bene.»
Posò le chiavi su una mensola di marmo e mi agganciò il cappotto su un appendino, accanto a una sciarpa grigia. Avanzai di un passo, ma nel farlo venni attraversata da una vampata di calore che mi provocò le vertigini; la vista venne invasa da una terribile sequela di spilli neri. Mi portò a barcollare sul tappeto, ma feci in tempo ad appoggiarmi al muro.
Desmond, dietro di me, mi afferrò dalle spalle. «Piano.»
Alzai un pollice, evitando di parlare, lui sospirò.
Pacato, mi indirizzò verso il divano, come il vento farebbe con una barca senza l'albero maestro, senza una vela, un timone, un capitano, la facoltà di decidere dove approdare. «Non ti chiedo neanche se hai mangiato. Immagino che la risposta sia un no secco.»
Mi rilassai sul poggiatesta e annuii, grata che più o meno conoscesse già il mio modo di elaborare il nervoso. Mentre sentivo il sudore imperlarmi le tempie, seguii i suoi movimenti intanto che, frettoloso, impilava dei documenti che occupavano l'altra metà del divano e, compattandoli insieme, li sistemava sul tavolino di fronte. Infine, recuperò una coperta a quadri.
«Ti preparo un brodo caldo?»
«No, non me la sento.»
«Qualcosa la devi pur mangiare.»
«No, davvero... Preferisco un'aspirina.» Mi raggomitolai su me stessa, la spalla e la guancia contro lo schienale.
Tornò con un bicchiere d'acqua e una compressa, che buttai subito giù. Dopodiché sprofondò nel posto accanto, strofinandosi il viso con un gesto fiacco e piegando l'altro braccio sopra di sé, sulla spalliera. Chiuse gli occhi. «Rimango io qui. Tu dormi pure in camera mia.»
«No, non se ne parla. Il divano mi va benissimo.»
«Hai un aspetto orribile. Fatti una dormita decente, almeno.»
Avvertii le lacrime tornare a bussare, il labbro prese a tremare.
Aprì gli occhi e, girandosi, se ne accorse. «No, dai, non piangere.»
«È che... non so come ringraziarti.» Repressi un singhiozzo e schiacciai la faccia sullo schienale. «Mi dispiace fare la parassita.»
Rise. «Ma smettila. Parassita. Mi hai movimentato la serata.»
«Cosa dici?»
«Mettiamola così: se non fossi venuta, non avrei mai trovato la scusa per riordinare questi documenti dal divano. In tutta probabilità sarebbero rimasti qui minimo un'altra settimana, o due. Eh già, difficile da credere, ma ho dei difetti atroci: quando sono preso da qualche progetto particolarmente importante dimentico il mondo che mi circonda e divento un accumulatore seriale.» Mentre mi strofinavo il naso mi sfuggì una risata singhiozzata. Lui sorrise. Poi allungò una mano per rimuovermi una lacrima dalla guancia, col pollice. «Non piangere, ok? Non mi piace vederti così. Anzi.»
Scattò ad allungarsi sul tavolino di marmo.
Agguantò un tablet, lo accese dal tasto laterale e, dopo aver attivato un'applicazione, cominciò a far strisciare il pennino sullo schermo per diversi minuti. Rapido, diligente, senza battere palpebra. Nel giro di poco lo roteò nella mia direzione, mostrandomi quella che dovevo essere io in una modalità... caricaturale, umoristica.
Col cappuccio del pennino picchiettò sulla testa dalle proporzioni esagerate; sorridevo euforica, e dei fiorellini fluttuavano intorno al mio viso, come a voler simboleggiare un umore gioioso. «Questa sei tu.» Premette su un tasto e l'immagine cambiò: ero sempre io ma con due fontane che sgorgavano dagli occhi strizzati, la bocca un forno rovesciato, e in fondo un cumulo di polvere, gente che correva, una persona che chiedeva disperatamente aiuto, le mani nei capelli. Dedussi fosse lui. «Questa sei tu quando piangi.» Premette di nuovo sul tasto e la variazione mi fece coprire gli occhi per poi scoppiare a ridere: le fontane erano rimaste, ma era tutto allagato e c'erano fogli che galleggiavano. In fondo, dove avrebbe dovuto esserci lui, usciva solo la mano. «E questa sei tu se continui. Quindi, ti prego, non allagarmi casa. C'è il lavoro di una vita, qui.»
Mi strofinai le palpebre. «Sei molto bravo.»
Si inclinò a posare il tablet sul tavolino, grattandosi le ginocchia. «Grazie, ma spero sia dello stesso avviso la casa editrice a cui proporrò il mio progetto.»
«Quello che mi accennavi al Jolly Roger?»
«Già.» Con un mezzo sorriso si rilassò sullo schienale, a gambe divaricate. «Ti dirò la verità: dopo sei rifiuti la sto prendendo con molta leggerezza. Se è destino che l'accettino bene, se no amen.»
Mi accoccolai nella coperta. «Stai lavorando a un fumetto?»
«Graphic novel. Preferisco lavorare a progetti autoconclusivi.» Diede due colpi di tosse, fissando davanti a sé, perso. «Osservando i miei nipoti, all'inizio pensavo a qualcosa per bambini. Ma riflettendoci meglio vorrei tentare di fare qualcosa di più. Pensavo a un racconto parlato dalla prospettiva di un bambino, nel suo linguaggio, ma che tra le righe facesse emergere qualcosa di delicato, una tematica odierna, che magari viene ancora vista come un tabù.»
«Sia per bambini che per adulti.»
Si voltò, sorridendo. «Unire i due mondi. Esatto.»
«La trovo un'idea bellissima.» Mi tormentai le crosticine alle unghie «Effettivamente ci sarebbe un gran bisogno di sensibilizzare su tante, tantissime cose, sin da quando si è piccoli.»
Mi guardò, annuendo. Poi sospirò. Ci impiegò qualche istante prima di dire: «Ragazzina, però così non va bene. Ce ne stiamo a parlare di progetti che non vedranno mai la luce del sole mentre il motivo per cui sei qui è un altro. E sto ancora attendendo che me lo racconti».
Per un attimo avevo dimenticato dove mi trovassi e perché. Desmond era inconsapevole della capacità di distrarre una persona dai propri problemi, anche se solo per qualche minuto. E adesso che mi aveva ricordato di parlarne, il peso di ciò che avevo passato negli ultimi giorni tornò a gravare sul petto, all'improvviso, come un'incudine. Sebbene il magone mi suggerisse di riversare altre lacrime, cercai di resistere. Glielo dovevo dopo quei begli sketch sul tablet.
Fuggii dal suo sguardo. «Ho provato a seguire il tuo consiglio.»
«Ma?»
«Non è andato a buon fine» mormorai, rattrappendo le labbra in un sorriso infelice. «Temo che aggiustare sia impossibile, ormai.»
«Lo pensi tu?»
«Le persone di cui mi fido.»
Abbassò le sopracciglia, sistemandosi meglio a sedere. «Chi?»
«Mia sorella, i miei genitori... la mia famiglia.» Tamponai gli angoli umidi degli occhi. «Olivia mi ha fatto capire diverse cose a cui non avevo mai fatto caso su mamma e papà, e realizzarlo fa così male che ogni momento che trascorro dentro quella casa comincia a essere invivibile, irrespirabile, e...» Era come vedere ogni mattina, al mio risveglio, la fotografia di famiglia aleggiarmi davanti e tagliarsi in due, nel mezzo, dove c'ero io. Dovetti togliere l'ennesima lacrima sfuggita. «Scusa, la smetto. Però preferirei se... se non ne parlassimo adesso.»
Era probabile avesse intuito che, in quello stato discutibile, non ci fosse alcuna volontà di dare una spiegazione. Tuttavia, studiandomi le dita rovinate dai miei sfoghi d'ansia, ci adagiò una mano sopra, in modo tale che la smettessi di torturarmele. «Penso sia stata la citazione di uno scrittore egiziano, ma ricordo di aver letto da qualche parte che casa non è dove sei nato, ma dove cessano i tuoi tentativi di fuga» espose. «Se casa tua comincia a starti stretta, se certe cose ti fanno stare male, se preferisci scappare e fare questo.» E mi sollevò una mano, facendo riferimento ai segni intorno alle unghie. «Direi che è ora di parlarne con i tuoi. Lo sanno? Sanno cosa stai passando?»
Negai con la testa. «Se glielo dicessi... Olivia dice che...»
«Perdonami se sono brusco, ma al diavolo tua sorella» scandì. «È una tua necessità, Ophelia, tua, sei tu a stare male, non lei. Finché non senti conferma dalle bocche dei diretti interessati, non dovresti nemmeno dare tutto questo peso a quello che ti dice, mi hai capito?»
«Arriverebbero a odiarmi.» Deglutii un bozzolo acre, immaginando la mortificazione che avrei provato se fossi andata ad aggiungere loro un ulteriore motivo per tollerarmi. «Non lo sopporterei... Non riuscirei a sopportare se arrivassero a odiarmi.»
Si ammutolì. Tuttavia, tempo di un sospiro leggero, confessò più morbido: «Non credo sia possibile odiarti». Incredula, sollevai gli occhi proprio nel momento in cui premette la mano sulla mia fronte. E per qualche ragione, mi sentii accaldare alla base del collo. «Ma ne riparleremo domani, ok? Ora vado a prenderti un termometro.»
Si eclissò in uno stanzino dove compariva una mini scarpiera. Giunsero dei rumori di scatole che si aprivano e si chiudevano, poi qualcosa che cadeva, e un'imprecazione. In tutto ciò, mi accorsi solo dopo qualche secondo di starmi premendo la fronte, nel punto in cui era stata toccata.
Desmond rispuntò mentre analizzava tra le mani un termometro a mercurio. Lo agitò su e giù con delle bracciate vigorose e me lo porse. «Vecchio stampo. Quello digitale si è rotto tempo fa.»
«E tu non hai paura che io possa trasmetterti qualcosa?»
Afferrai il termometro, lui si grattò la barba rada, accomodandosi. «Tranquilla, ormai mi ammalo con niente. Con delle difese immunitarie così basse vado a lavorare pure con trentotto di febbre.»
Mi rabbuiai, fissando le cifre nello strumento. Sperai di non contribuire a peggiorargli la salute. Con la nebbia a ottenebrare i pensieri razionali, mi schiarii la gola per mascherare l'impaccio e mi liberai della coperta dalle spalle. La lasciai cascare sulle gambe, rimaste piegate dietro di me. Poi, inumidendomi le labbra screpolate, abbassai il colletto della maglia, lasciando che si denudasse uno spicchio di spalla, dove emerse la bretella trasparente del reggiseno.
La vergogna slittò in secondo piano; avevo altro in testa, altro a cui pensare. Dopotutto si trattava di qualche minuto. Quindi, inserii il termometro sotto l'ascella.
Nell'attesa, stanca, posai di nuovo la guancia sullo schienale.
Desmond, che scorreva rapido il pollice sul suo cellulare, appena lo mise giù sul cuscinetto girò il capo. Lo sguardo austero non si soffermò su di me, ma scivolò lentamente dal collo arrossato alle pieghe della maglia, alla spalla, sullo strato di carne esposto. Un baluginio di stupore gli attraversò le iridi scure, rendendogliele d'una parvenza più dolce. Ma fu un attimo, perché assottigliò le palpebre, assumendo un'espressione concentrata, incuriosita, e inclinò il volto.
Esitò per qualche momento, poi lo chiese: «Cos'è?»
Seguii lo sguardo. Ero convinta che quell'assurda idea che mi era venuta in mente quasi due anni prima fosse rimasto nascosta. Invece qualcosa emergeva lo stesso, ricordando a me stessa ciò che ero. Un po' mi rattristò. «Una cavolata fatta appena compiuti i diciotto anni.»
«Posso vedere meglio?»
«Certo.»
Si avvicinò di un posto e allungò la mano. A qualche centimetro dalla spalla esitò un paio di volte prima di fargliela aderire del tutto. Il pollice, fresco e ruvido, lambì delicatamente quel tassello di pelle pallida, premette sul bordo merlettato del colletto e, con estrema cautela, lo abbassò ancora, più giù, quel poco che bastava per far emergere l'interezza del piccolo tatuaggio. A una distanza così ravvicinata ebbi modo di ascoltare il suo respiro uscire dalle narici a cadenza regolare, e di studiargli delle particolarità che incastonate in viso, che non ero abituata a distinguere, ad esempio le lievi cicatrici che gli punteggiavano le gote come crateri, dovute a un'acne che supposi lo avesse perseguitato quando doveva avere la mia età.
«Una gabbia chiusa» disse a bassa voce, accarezzando le linee sottili di un disegno minimal. «Sono delle note musicali quelle che vedo uscire dalle inferriate?»
«Sì.»
«Carino.» Alzò gli occhi su di me. «Il significato?»
Assunsi un sorriso amaro, fissandogli il pollice. «Dipende dalla connotazione. Può rappresentare ciò che ero prima e cosa sto andando incontro adesso. Evoluzione e regressione allo stesso tempo. Una casa e una gabbia, a seconda della prospettiva. Voglia di evadere e voglia di restare prigioniera nella mia comfort zone. Un inno alla libertà o una disperata ricerca di aiuto.» Strinsi le labbra, torturando la coperta. «Le note rappresentano il canto, ciò che mi ha permesso di sbloccarmi dal mutismo selettivo da piccola, la gabbia è la casa della mia voce, ed è chiusa perché...» Ripensai a mio padre qualche giorno prima, in cucina, all'esortazione ad affrontare i miei tormenti, e avvertii gli occhi pizzicare. «Perché sono io a decidere se aprirla. Ma a volte, per la paura, dimentico di possederne la chiave e così...»
«Rimane chiusa.»
«Rimane chiusa.» Battendo gli occhi più volte ricacciai indietro le lacrime, focalizzando l'attenzione sulla sua spalla, le palpebre che iniziavo a farsi pesanti. «Anche io avevo... Anche io avevo notato una cosa, qualche mese fa.» Senza curarmi di sembrare invadente, sollevai lentamente l'altro braccio e con le dita sfiorai la sua spalla, facendogli compiere un tragitto circolare tra le pieghe della camicia. «Proprio qui. Quando eravamo andati al Jolly Roger.»
Per un po' seguì il percorso delle mie dita, serio. Poi sorrise.
«A differenza del tuo è impossibile da non notare.»
«Posso vederlo?»
«Solo se non mi dai dell'egocentrico.»
Stupita, mi venne da ridere. «C'è questo pericolo?»
Si raddrizzò, sbottonando con nonchalance i primi tre bottoni della camicia. «Diciamo che appena lo vedrai, potresti farti due domande.»
Interrogativa, tenni la mano sospesa per aria. Intanto, abbassò il colletto e la porzione sinistra della camicia. Contrariamente al mio spicchio di spalla, lui dovette mostrare molto di più: non riuscii a trattenermi dall'impulso di arrossire quando, sotto il pomo d'Adamo definito, notai i muscoli del collo tendersi, dove sparsi qua e là piccoli nei costellavano la pelle, vidi sporgere le clavicole come lievi dossi, e spuntare della peluria al centro dei pettorali.
Sembrava non trovare alcun tipo di imbarazzo.
A spalla scoperta, si dovette girare e rivolgermi la schiena, tenendo giù la camicia con una mano. Socchiusi le labbra dalla meraviglia. Lo schizzo d'inchiostro che gli avevo scorto al mare acquistò un senso: dalla scapola sinistra, come se si trattasse di un'ulteriore estensione vertebrale, come se facesse parte di lui, erano state tatuate una serie di penne compatte tra loro.
Un'ala nera e solitaria seguiva fedele un percorso preciso, a triangolo, dispiegandosi sopra la spalla. Tuttavia, più il mio sguardo scalava sulle piume, più l'inchiostro schiariva, si impallidiva.
Desmond, con un colpo di tosse, tornò alla posizione iniziale, guardandomi. Ma io, sorpresa, mi ero fossilizzata sulla sommità della spalla. L'inchiostro delle penne, lì in cima, era bianco.
«Dio, è meraviglioso.»
«E la domanda?»
Fu più forte di me, quasi volessi accertarmi che non fossero vere: sfiorai piano le tracce d'alabastro, cicatrici che tracciavano delle penne, valorizzando qualsiasi significato si celasse dietro all'intero tatuaggio. Avevo ammirato una bellezza del genere solo una volta, quando avevo scoperto cosa il folclore giapponese nascondesse dietro ai vasi dalle venature dorate.
«Perché?»
«Perché l'aquila è sempre stato il mio animale preferito. Sai, amavo i documentari sui nostri nativi, l'importanza e la storia dietro ai loro totem, e inoltre, non so se ne sei al corrente, è presente anche nello stemma dell'NSA. Già, da bambino sognavo di far parte dei servizi segreti.» Mi strappò una risata, ricordando che Gregg, durante il mio primo colloquio, aveva fatto dell'ironia in merito. «Ma in realtà ci ho sempre visto l'incredibile capacità di raggiungere quote altissime, che solo là in alto, secondo me, riesci a cambiare la prospettiva delle cose. Il nero che sbiadisce finché non sbianca simboleggia le nuvole, la libertà che l'animale assorbe.»
Seguii quelle linee, con un sorriso. «Ti si addice.»
«E tu?» chiese dopo un po'. «Qual è la tua visione?»
Cominciai a vedere più sfocato, il disegno che sporgeva dalla spalla sfumava con la sua carnagione. «Da nero a bianco... Un'aquila che vola troppo in alto ma che desidera essere un po' un angelo. Hai parlato di libertà, ma io ci vedo anche tanta protezione, tanto riparo.»
Trovai il coraggio di guardarlo, ma nonostante vedessi a tratti appannato e a tratti distorto, notai la sua espressione cambiare, rivestirsi di una luce malinconica e severa al contempo, una luce mai vista. Per qualche lungo istante, ci guardammo e basta, senza che altre parole uscissero dalla mia bocca. O almeno, questo finché le palpebre cedettero alla stanchezza.
Non sentii Desmond aggiungere altro, o forse avrebbe voluto ma si vedeva che non lo ritenne il caso; per cui mi sfilò il termometro, mi risistemò il colletto della maglia e, vedendomi rabbrividire, mi sistemò la coperta sulla spalla, cauto come solo lui sapeva essere.
«Per prima» mugugnai, appena si alzò. «Avrei scelto l'aquila.»
ANGOLO AUTRICE
Buoooongiorno, nightingales! 🕊️
Sì, lo so, il countdown precisava un aggiornamento alle 15:30, ma come al solito ho voluto rivedere certi passaggi e sperare che fosse il più decente possibile, perché questo capitolo, per me, è IL capitolo. Una sorta di punto di svolta per le vite dei protagonisti, per le loro sorti all'interno della storia. (Che poi la sorte gliela decido io, ma comunque).
Non sapete quanto mi sia piaciuto scriverlo, sebbene in certi punti l'ho trovato abbastanza complicato da stendere. Ma penso che questo, insieme al capitolo della cena, sia uno dei pochi che mi sia piaciuto davvero, dall'inizio alla fine. Due su venti, not bad, Lara.
Questions:
▪️ Oliva & Ophelia; il loro rapporto, dalla parte di Ophelia, si sta sgretolando sempre di più. Con l'ennesima dimostrazione che Olivia non sembra più quella di un tempo, Ophelia inizia a temere persino di parlarle. Ricordate che nello scorso flashback era stata proprio lei ad averle chiesto se un giorno le avesse insegnato a cantare, visto che non è capace. Da lì si può dedurre che comunque ammirasse Ophelia, in qualche modo. Chissà col tempo cos'è cambiato?
▪️ Per Ophelia, le parole della sorella sono un po' la goccia; si spegne molto più di quanto già non fosse. Ricordiamoci anche che Olivia rappresenta il suo faro, il suo costante appoggio, un esempio che il più delle volte, da bambina, si era imposta di seguire. Vedendo che il suo punto di riferimento comincia a non apprezzare ciò che fa, lei stessa si sente disorientata. Senza contare di ciò che Olivia le ha sempre riferito in merito alle bugie dei suoi genitori. Arriveremo a un confronto, prima o poi? Ophelia parlerà una buona volta con mamma e papà? Proverà ad ascoltare meno sua sorella? Troverà la sua strada? Si staccherà da questo rapporto malato?
▪️ Cindy, piccola birbantella, ma anche grande osservatrice: la ragazzina ci ha visto lungo con quella domanda? Dite che Ophelia inizierà a dare un certo peso al suo rapporto con Desmond?
▪️ Alla fine Ophelia, a forza di trattenere, esplode; senza volerlo scoppia a piangere davanti ai disegni (simbolici, ovviamente - ormai avete capito che questi animali ci perseguiteranno durante la trama 💀) di Desmond; lui avendo avuto modo di conoscerla, capisce che dietro ai suoi silenzi e all'ostinazione di non riuscire a spiegare bene cosa le stia accadendo, le dona tutto l'appoggio possibile, accettando di ospitarla a casa sua. Angelo custode non per niente (il titolo scelto non a caso). Oltretutto scopriamo diverse cose su di lui: i suoi progetti, il suo modo di vivere, il suo modo di tirare su il morale a Ophelia. Cosa vi ha colpito di più su di lui?
▪️ I tatuaggi; punto focale dell'ultima parte che svela tanto di entrambi. Dalla parte di Ophelia neanche tanto (però non vedevo l'ora di narrare del suo tatuaggio), ma dalla parte di Desmond c'è tanto. Egocentrismo o no (ahahah) con la questione del disegno? Questo loro toccarsi a vicenda, di scoprirsi, di avvicinarsi, di sentirsi, non è mai messo a caso: inconsapevolmente si sta costruendo fra loro una base d'intesa molto forte, e nemmeno se ne rendono conto. Qual è stata la vostra parte preferita? La presenza di Desmond aiuterà Ophelia a "cambiare prospettiva"?
Noi ci vediamo col prossimo chap - stra di passaggio e cortissimo GIURO - ma che non vedo l'ora di scrivere. Già mi mangio le unghie. Curiosi? 🕊️
Intanto ci tengo, come sempre, a ringraziarvi per la vostra presenza e il vostro sostegno. ❤️
Playlist:
Bird Song - Florence + The Machine (prima parte - la parte in cui Ophy la canta)
https://youtu.be/IKuFy9ayQrg
Your Song - Ellie Goulding (prima parte - da quando arriva Olivia fino alla fine)
https://youtu.be/D9AFMVMl9qE
Keep Me Warm - Ida Maria (seconda parte - fino a quando Des non le mostra i disegni)
https://youtu.be/-kyhZGAQnNo
Delicate - Damien Rice (seconda parte - da lì fino alla fine della parte)
https://youtu.be/k503KMS7bak
Need You - Hazey Eyes (terza parte - fino a quando Des non si alza per il termometro)
https://youtu.be/DPyyunnqn3M
Touch - Sleeping At Last (terza parte - da lì fino alla fine)
https://youtu.be/ZtgxwkIhH5M
Instagram: The_blackcatshadow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro