14. Dare e avere

Dare e avere
Prima
Dare e avere. Due fratelli che non sempre andavano d'accordo.
Quando ancora frequentavo le scuole elementari, mi accorgevo sempre più spesso come i bambini della mia età, tra loro, dessero con la speranza di ricevere qualcosa in prestito; dare Barbie Raperonzolo per poter avere l'onore di giocare con la Barbie Schiaccianoci dell'altra, passare un pastello dorato per provare una biro profumata, concedere un sorriso alla maestra per riscuotere un riconoscimento, aiutare nei compiti per ricevere il permesso di copiare nelle verifiche. E così via.
Una volta, ottimista, avevo provato anche io a rincorrere quella corrente di pensiero che girava tra i banchi. Inutile dire che l'esperimento era miseramente fallito nel giro di pochi secondi.
Il motivo non era poi così difficile da indovinare: ero partita in una posizione di svantaggio, prigioniera d'una capacità comunicativa davvero esigua. Poiché la voce, quel secondo timido cuore che in gola non faceva che pulsare frasi sconnesse e voglia di urlare, non era un amico su cui fare affidamento. E riuscire a spiccicare due parole con i miei genitori non era l'ultimo traguardo, bensì solo il primo dei tanti.
Per quella grave mancanza, che vedevo tanto come il crollo di un ponte comunicante con gli altri bambini, spesso e volentieri rivestivo i panni di un'incognita che si guardava con quegli occhi un po' stretti e un po' dubbiosi. Perché ero una presenza-assenza, una bambina in carne e ossa ma che, paradossalmente, aveva un fantasma come voce.
"Sì, c'è, ma se non esistesse sarebbe la stessa cosa."
"Se non parla come fa a giocare con noi?"
Frustrante minimizzava il mio reale stato d'animo. In quei momenti le parole che Cordelia rivolgeva ai suoi alunni risuonavano più prepotenti che mai tra le sinapsi. "Alzala quella voce, se no il pubblico non ti sente, non ti vede", "Se non ti fai sentire per bene, molto difficilmente capiranno che sul palco c'è una persona".
Avevo capito che sentire e vedere condividevano lo stesso DNA.
Ripensando a quel maldestro tentativo di imitare i miei compagni, ridevo tra me e me per essermi comportata da ingenua; rinchiusa nel mio mutismo, avevo prestato una matita a una bambina che aveva perso la sua, ma né aveva barattato qualcosa dal suo astuccio, né mi aveva mai restituito quanto gli avevo concesso. Mi ero domandata se quell'errore di calcolo fosse dovuto a causa di ciò che mamma rimproverava ai suoi alunni: per non aver parlato, per non essermi fatta sentire. Non era così; a quanto pareva la voce non c'entrava nulla, e quel dare e avere possedeva evidenti falle, perché non tutti si dimostravano propensi a ricambiare la gentilezza. Anzi, esisteva chi rifuggiva da esso, scappando, ricambiando con l'inganno. I miei lo sottolineavano spesso: le lezioni migliori arrivavano quando ci si sbatteva la testa. La vita era un'eterna masochista, dicevano, e secondo una logica assurda, per poter stare bene bisognava prima stare male.
Messaggio ricevuto.
Qualche tempo più tardi, in compagnia di Olivia e nostro padre, avevamo passato un pomeriggio estivo ad assistere a una partita di pinkleball e poi a una di baseball tra i ragazzini del club sportivo giovanile di Chestnut Hill. Mia sorella mi aveva spiegato le regole, quando si vinceva, cosa significavano certi termini che si gridavano i giocatori.
Era stata una giornata appagante, che ricordavo col sorriso.
A riequilibrare il caldo torrido che si appiccicava sulla schiena, papà ci aveva concesso di rinfrescarci alla gelateria poco lontano dal campo, Chill on the Hill, munendo Olivia di qualche dollaro, così che avrebbe pagato anche per me. Lei si era scelta una coppetta gelato di yogurt ai mirtilli, io un glorioso cono cheesecake alle fragole. Ne ero dipendente, persino nei gelati.
Dopodiché, ci eravamo incamminati in direzione del parcheggio, delimitato da una recinzione che lo separava dalla strada principale. Gli sghignazzi di papà e Olivia per il modo in cui mi si impiastricciava continuamente il naso di crema si erano sovrapposti alle gare che lei mi incitava a fare per arrivare per prima alla macchina. E io la inseguivo ridacchiando, ero la sua ombra, le mani protese in avanti affinché il gelato non gocciolasse sulle scarpe da ginnastica nuove.
Giunte davanti alla portiera, avevo notato ai piedi della ringhiera, dal lato opposto rispetto alla nostra posizione, una donna accomodata su quella che pareva tanto una coperta sdrucita. Poteva essere anziana come poteva non esserlo, visto che la trascuratezza che le sommergeva il viso olivastro gli regalava anni che scommettevo non le appartenessero. Ad ogni modo, non era la prima volta che incontravo individui che si rifugiavano lungo i marciapiedi.
L'avevo indicata, col dito sporco.
Olivia, al mio fianco, aveva tirato fuori dalla borsetta una salvietta umidificata e aveva scrutato il punto. Poi mi aveva consigliato delicatamente di abbassare la mano, mentre me la puliva per bene.
«Non indicare, Ophelia. È da maleducati.»
«Perché?»
«Beh, può sentirsi osservata, o minacciata. Non è bello avere gli occhi puntati addosso» aveva detto, mentre mi strofinava anche gli angoli della bocca. Io avevo mantenuto lo sguardo sulla donna.
«Cosa fa?»
«Riposa.»
«E... casa?» Mi ero morsa il labbro. Odiavo singhiozzare le frasi, sebbene in testa fossero corrette e scorrevano come olio. Purtroppo finivo per concluderle in una maniera imprecisa, o incompleta. Era uno degli innumerevoli motivi che mi portava a sembrare un'analfabeta di fronte agli occhi infantili dei bambini con cui cercavo di costruire quel ponte di comunicazione.
«Eh, purtroppo non ci va.»
«Perché?»
Aveva riso, andando a gettare la salvietta in un bidoncino da cui straripavano dei fazzoletti. «Fai troppe domande per essere taciturna.»
Intanto che Olivia si allontanava, io mi ero girata indietro, dove papà se la stava prendendo comoda. Mano in tasca, l'altra che reggeva il telefono. Sorrideva e gesticolava, mentre conversava con chiunque stesse parlando. Ogni tanto si sistemava gli occhiali oltre la gobba.
L'avevo raggiunto con una corsetta, superando un paio di macchine parcheggiate. Mia sorella aveva deciso di rimanere vicino alla nostra. Quando mi ero trovata accanto a lui mi aveva accarezzato i capelli, mentre lo sentivo aggiornare mia madre sul baseball e il gelato. Gli avevo sfilato la mano dalla tasca, ignorando che fosse impegnato al telefono, e avevo iniziato a tirarlo.
Lui aveva corrugato le sopracciglia, sorpreso. «Ehi.»
«Vieni.»
«Dove?»
«Vieni.»
Lo tiravo e tiravo, poi si era arreso, salutando Cordelia dall'altro capo della telefonata. Quindi l'avevo convinto a velocizzare il passo mentre lo trascinavo in direzione del punto in cui ero prima. Lì, gli avevo indicato la signora che sonnecchiava, la testa che ciondolava, un cane che imitava la padrona standole ai piedi, con la testa tra le zampe.
«Chi è?»
«Beh.» Si era grattato la testa. «Una senzatetto.»
Senzatetto. L'avevo masticato tra i denti. «Cosa significa?»
Olivia, nel frattempo, vedendo che ci eravamo bloccati a parlare, ci aveva raggiunti. Vedendola, papà si era rivolto a lei con un sorriso. «Forza, sorella maggiore, spiegale cos'è una senzatetto.»
Si era stretta la coda alta, scrollò le spalle. «Una senzatetto è una persona che non ha un lavoro e non si può permettere una casa. Non ha più soldi e non può farsi aiutare.»
«Fosse solo quello» aveva sospirato lui. «A volte è gente che ha paura, che fugge da una brutta situazione, magari è gente malata che non riceve l'aiuto che merita, o ripudiata dalla sua stessa famiglia.»
Non avevo staccato gli occhi da quella donna; si era svegliata dal sonnellino e si era messa a dare una grattatina sul capo del cane, poi aveva frugato in uno zainetto che aveva collocato a fianco, estraendo una bottiglia. Ero sicura, anche senza sollevare il viso, che papà mi stesse osservando. Come se avesse frugato tra i miei pensieri, aveva cominciato a tastarsi le tasche.
Poi si era chinato sui talloni, arrivando alla mia altezza e porgendomi qualche dollaro sul palmo. «Ti piacerebbe aiutarla?»
«Si può?»
«Certo. Il massimo che possiamo fare per loro è proprio questo.» Avevo stretto le banconote, una strana felicità si era fatta largo nel mio petto. Stavo già andando, ma mi aveva bloccata. «Liv, accompagnala.»
Olivia mi aveva presa per mano. «E se quel cane morde?»
«Non lo farà, tranquilla.»
«Non mi piacciono i cani...»
«Ti difenderà Ophelia, in caso.»
Olivia, ridendo, gli aveva mostrato la linguaccia.
Davanti alla donna avevo capito che non era così anziana come sembrava. Non aveva proferito parola, ma ci aveva osservate con un timido sorriso a rinvigorire quelle labbra spaccate. Una costellazione di lentiggini e sporcizia invadeva un volto troppo magro, dove sporgevano degli zigomi come catene montuose, e i capelli raccolti, che dovevano essere biondi, erano talmente trascurati da renderli di una tonalità più cupa, che si avvicinava tanto alla cenere.
Il cane, un cocker dal pelo bruno, teneva gli occhi chiusi.
Mia sorella aveva fatto cenno a un barattolo di latta aperto, dove al suo interno erano già state depositate un paio di banconote e qualche triste spicciolo. Mi ero chinata e avevo allungato il braccino oltre il muso addormentato del cocker, stando ben attenta a non svegliarlo.
La donna aveva giunto le mani rovinate e ci aveva rivolto un sorriso capace di renderla più bella. «Che Dio vi benedica, ragazze.»
Come per la bambina e la matita mai restituita, anche qui avevo dato e non avevo ricevuto nulla. Eppure, c'era una differenza: questa volta era come se la signora mi avesse dato qualcosa, qualcosa che andava al di là di un oggetto corporeo, qualcosa che possedeva un egual valore con quel sorriso che viaggiava da guancia a guancia e la voce che le tremava dalla gratitudine. Avevo compreso che il dare, da solo, viveva anche senza l'avere, e che pure due fratelli come loro, per quanto uniti, potessero trovare una loro felicità persino da separati.
Quel gesto era stato l'inizio.
Sempre più spesso, quando capitava che uscissi con la mia famiglia, chiedevo degli spiccioli a mamma o a papà da offrire a qualche senzatetto che incrociavamo sui marciapiedi della Germantown Avenue. Mi ero intestardita a non mollare la presa a quella felicità, una felicità incompleta, di dare senza l'avere. Ed era stato quello uno dei motivi per cui, al secondo anno di liceo, mio padre aveva acconsentito affinché potessi sperimentare attività di volontariato presso il Faith Rescue Mission, rifugio per senzatetto a Center City.
All'epoca ci lavorava mia nonna paterna prima che passasse a miglior vita; di lei conservavo dei ricordi un po' sbiaditi, ma la bontà d'animo che le illuminava gli occhi chiari era rimasta indelebile.
Pur avendo solo quindici anni, grazie alla sua supervisione e a un'autorizzazione scritta di papà, ero riuscita sfruttare i fine settimana in quel luogo perennemente affollato, tra il servire i pasti alla mensa e l'aiuto nelle pulizie. Nei momenti in cui nonna Margery mi concedeva qualche minuto di tregua, mi sedevo ai tavoli, in mezzo ai senzatetto, provando a scambiarci due parole. Sembrava non aspettassero altro che qualcuno gli desse il via; non facevano che chiacchierare fino a farsi seccare la gola, tra un boccone da un piatto di plastica e un vigoroso sorso d'acqua.
Con la vorace curiosità di un avventuriero in mezzo a delle rovine, osservavo entusiasta il mutamento d'espressione in quelle facce diverse, dalle carnagioni più disparate, e mi lasciavo travolgere dal fiume di parole di chi sembrava avere tutto ma in che in realtà non possedeva più nulla. Io davo loro l'opportunità di avere un orecchio che li ascoltava, e in cambio ricevevo moltitudini di esperienze, prospettive della vita dalle sfumature differenti, racconti sui viaggi spericolati degli eremiti, i trucchi per farsi bastare il frutto di una misera elemosina fino al giorno dopo, la fermezza di un veterano mentre alzava un braccio mozzo e spiegava di "quella fatale granata", o ancora, l'agghiacciante realtà di chi, in inverno, ricercava del calore facendo uso di eroina. Altri, invece, si rifugiavano nel circolo della droga per sopravvivere alla depressione che portava l'esperienza sulla strada.
Dare e avere. Da bambina era solo una minuscola sensazione, a quattordici anni era diventata una concretezza: il niente racchiudeva in realtà un grande patrimonio che la sera, a cena, condividevo con tutta la mia famiglia.
Per mesi, però, una signora aveva cominciato a fissarmi.
All'inizio fingevo di non notarla quando passavo tra i tavoli. Tuttavia era sempre lì, a tenermi d'occhio, al che era sorto in me uno strano senso di agitazione. L'avevo segnalata alla nonna, ma lei aveva minimizzato dicendo di non darci peso, che a loro piaceva osservare.
Poi, una sera, nella piccola cappella allestita accanto alla mensa, mi era stato concesso di ascoltare i leader spirituali e il messaggio giornaliero sulla parola di Dio, un incoraggiamento a diffidare dalle calde braccia delle tenebre e a non perdere la speranza, che la luce in fondo al tunnel si raggiugeva sempre. I senzatetto si contavano sul palmo di una mano, e quelli che partecipavano erano sempre gli stessi.
«Posso?»
Era stato un tono di voce talmente basso che credevo fosse uscito dalle bocche di chi stava proferendo la parola del Signore. Soltanto quando mi ero voltata avevo capito fosse la signora che continuava a fissarmi. Quindi mi ero sbrigata a farle spazio sulla panca, lei aveva arrancato a passo zoppo, con delle calzature spellate e, dove finivano le maniche, avevo notato sbucare macchie violacee. Sul viso portava segni simili, specie sulle tempie e gli zigomi, ma erano più tenui.
Guardava davanti a sé, l'eco di chi parlava l'unico rumore.
Poi mi aveva sussurrato: «Credi nell'Onnipotente?»
Avevo studiato il suo profilo, la serenità cosparsa negli occhi scuri, scavati nella pelle smunta. Non si era girata. «Sì, qualcosa del genere.»
«Come mai?»
Mi ero strofinata le dita, infine gli anelli. «Diciamo che ci sono state alcune cose mi hanno spinta a credere in qualcosa che va oltre.»
«Per esserne convinta immagino tu abbia assistito a un miracolo.»
«Una specie. Anche se non l'ho assistito in prima persona.»
Aveva trattenuto uno sbuffo dal naso, arrotolando piano la manica, e aveva esposto quegli ematomi che sembravano profonde pozzanghere di crudeltà. «Li vedi questi? Da quando mio marito aveva iniziato a lasciarmeli addosso ho smesso di crederci. Non mi sono sentita protetta come avrei voluto, e a quanto pare trovare rifugio in Lui non bastava per salvarmi da questo. Io gli donavo la mia fede, ogni mattina, ogni sera, e in cambio ho ricevuto il Suo abbandono.»
«Mi dispiace tanto» mormorai rammaricata. «Sei scappata?»
«Dovevo.» Aveva tirato giù la manica. «Ho capito che la salvezza te la trovi da sola, con le tue forze. Quando inizi a contare su quelle degli altri, il loro abbandono fa più male di questi lividi.»
Avevo annuito, non sapendo che altro aggiungere.
Pochi secondi dopo, però, era stato più forte di me chiederle: «Se non risulto troppo indiscreta... perché continuavi a guardarmi in questi giorni?»
Aveva scrollato le spalle. «Così. Semplice curiosità. Mi piace osservare i giovani volenterosi.» Si era voltata e, distrattamente ma con fare materno, mi aveva preso le mani, riscaldandole tra le sue. Gliel'avevo lasciato fare, anche quando aveva preso a studiarmi il viso con vivida attenzione. Occhi, naso, guance, bocca, fronte. Pian piano che osservava, i suoi occhi aveva cominciato a rivestirsi di una patina lucida. «Posso chiederti come ti chiami?»
Non avevo saputo interpretare quel cambiamento nel suo sguardo, nel tono. Allora avevo lasciato perdere, piegando le labbra in un sorriso. «Ophelia.»
«Bel nome.» Aveva stretto le labbra e, sbrigativamente, aveva rivolto lo sguardo davanti a sé. Non mi era sfuggito il passarsi le dita agli angoli degli occhi. «Questa maledetta allergia.»
«E tu? Il tuo nome?»
«Un nome molto più brutto rispetto al tuo.» Si era tamponata le palpebre con un fazzoletto, accennando una risata. «Judy, comunque.»
«Judy» ripetei, poi fui io a stringerle la mano. «A me non dispiace.»
Qualche tempo più tardi mi avrebbe spiegato che non era l'allergia quella che aveva cercato di togliersi inutilmente dagli occhi arrossati.
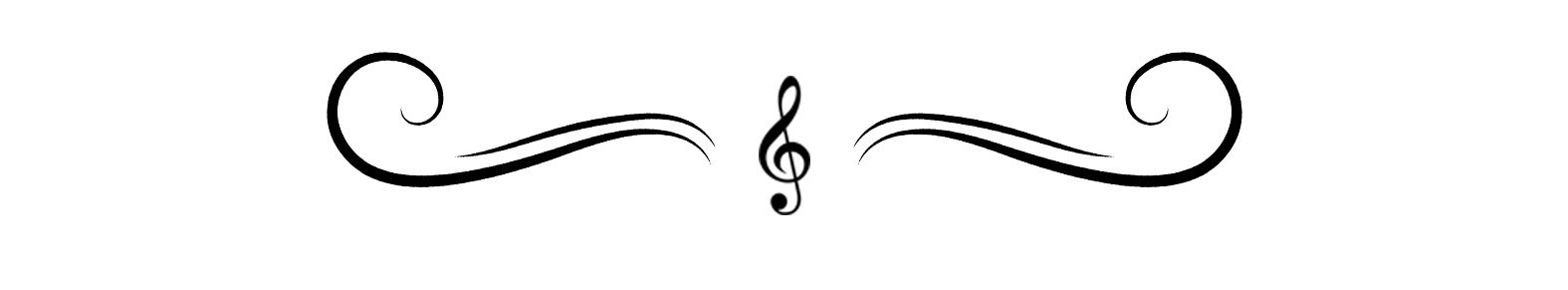
Adesso
«Ehi, ciao.»
Nessuna risposta.
«Vedo che oggi sei un po' più trascurata del solito... Ma non ti preoccupare.» Infilai la mano in un sacchetto di plastica, di quelli che rifornivano i supermercati, e tirai fuori una bottiglia d'acqua, mormorando tra me e me, come se potesse sentirmi: «Ora ci sono io».
Inginocchiata davanti a una lapide senza un'identità, una decorazione o una fotografia, mi accinsi a darle una spolverata lungo la facciata grigia e intorno al bordo arcuato con uno straccio logoro che mi ero portata da casa. Non badai all'erba madida di rugiada che mi stava inzaccherando i jeans, e molto delicatamente strofinai ogni angolo in cui tracce di fanghiglia imbruttivano un volto di pietra in cui emergevano solo un nome e una dedica come unici tratti fisionomici.
"Perché ogni vita umana ha lo stesso valore."
«Mi spiace se non mi sono più fatta vedere, ma il nuovo lavoro mi ha impegnata con i turni.» Arrotolai lo straccio attorno all'indice e lo passai nei solchi delle incisioni, lettera per lettera, con tatto, quasi temessi che il mio tocco potesse in qualche modo rovinarle. «Sto bene lì, sai? È una bella famiglia. Hanno i loro problemi, ma son sicura che li risolveranno.» Inumidii le labbra, passando l'altro lato dello straccio alla base impolverata, dove veniva accarezzata dagli steli d'erba. «Gregg è un padre premuroso e parecchio impegnato con l'ospedale, Cindy ha bisogno di ascoltare, Leonard di parlare, e Desmond è un po' il collante che cerca di compensare l'assenza del fratello, ed è attento.»
Infilai un guanto e tolsi una ragnatela rintanata in un angolo.
«Troppo attento...»
Sfilai il guanto, nel farlo rimasi a fissarlo per qualche secondo di troppo. Lasciai perdere e svitai la bottiglia d'acqua, rovesciandola sopra la lapide, una doccia che andò a detergere e a purificare tutti i giorni di buio che aveva dovuto sopportare chi riposava là sotto.
«Ma forse non ti importerà, vero?» Osservai la pietra lucidata, e poi intorno a me. In quella vasta landa di verde e di lutto, tante pietre sepolcrali spuntavano come piccoli colli. Una profonda malinconia mi pervase quando mi resi conto che le altre avevano un'identità e, soprattutto, una fotografia affinché il loro ricordo non sbiadisse mai. Con gli occhi su una lapide a forma di crocifisso, poco lontana, mormorai, sebbene la voce tremasse: «Forse ti chiederai come stia io».
Scossi leggermente la testa, sentendo le iridi pizzicare.
«Non lo so.» Simulai una risata, ma uscì solo un'amarezza condita da un'incontenibile voglia di piangere, sfogarmi, urlare. «La verità è che... non sto capendo più niente. Non capisco cosa stia succedendo.»
Abbassai lo sguardo sulle mani, arrossate ai polpastrelli.
«Io voglio bene alla mia nuova famiglia, gliene voglio così tanto...» Tirai su col naso, il viso rivolto al cielo azzurro, sgombro dalle nuvole. Chiusi gli occhi, respirando una, due, tre volte. Ma non bastò a rendere la voce meno rotta, o il cuore meno gonfio. «Eppure non capisco perché mi senta così di troppo, in mezzo a delle persone che hanno voluto farsi carico di me e dei miei problemi... Non capisco, non capisco davvero» mormorai, asciugandomi una lacrima. «Forse si sono pentiti di aver scelto me? Forse Olivia ha ragione, no? Troppe delusioni, troppi problemi. Mi hanno dato tantissimo e io gli sto restituendo delle difficoltà di cui non mi vogliono parlare... Mia sorella dice che mi ritengono troppo fragile perché possa ascoltare la verità, dice che avrebbero i sensi di colpa se crollassi, specie dopo ciò che era capitato qualche anno fa.»
Asciugandomi la guancia, il palmo si soffermò sul punto incriminato, dove fino a qualche giorno prima permanevano i graffi dovuti allo schiaffo. Stavano andando via, ma non dalla mia coscienza.
Lì erano cicatrici fresche, bruciavano ancora.
«A volte vorrei...» Strinsi le labbra, le arricciai all'inverosimile, cercando di trattenere lo sfogo che ingombrava nel mio petto. Ma non volevo mettermi in ridicolo. Non lì. «A volte vorrei averti conosciuta, solo per qualche secondo, solo per potermi aggrappare al volto di una persona che ha passato molto peggio di così e darmi quell'incoraggiamento in più per sopportare, perché...» Di nuovo, divampò il fotogramma di mia sorella che alzava la mano e colpiva, una furia silente incastonata in quelle iridi. Bastò perché un'altra lacrima mi accarezzasse la gota, ma non l'asciugai: lasciai che si scontrasse con l'erba, divenendo rugiada. «Perché così non ce la faccio» sussurrai, chinando il capo. «No, non ce la faccio proprio.»
Risollevai il viso, lessi il nome.
Decisi di conservare l'afflizione per un altro momento, e dal sacchetto sfilai un mazzo di gerani scarlatti, i gambi legati da un nastro rosso. Li sostituii a quelli che ormai decadevano nel piccolo vaso di vetro che, anni addietro, avevo sistemato a fianco alla lapide.
Perlomeno c'era un po' di colore.
Coi pugni chiusi, le nocche sfregarono sotto le palpebre strizzate, e imposi a me stessa di tornare a uno stato dignitoso. Dopodiché, osservando in trance quella facciata vuota, allungai la mano e la feci aderire sulla superficie, le dita estese. Era come se, ingenuamente, mi aspettassi di avvertire palpitare un cuore al di là della pietra.
Anche se c'è della terra a dividerci, anche se non c'è il tuo corpo qua sotto, ma solo una scatola contenente le tue ceneri, spero tu senta che non sarai mai dimenticata. Anche se non ti ho mai vista, anche se non ho mai avuto l'opportunità di amarti, di conoscerti, di abbracciarti, di dirti che non sei sola, che non ti giudico per quello che hai fatto, che meritavi più comprensione, più ascolto, più tatto.
Nemmeno mi resi conto di uno lieve spostamento d'aria al mio fianco e dei passi morbidi che si avvicinavano calpestando l'erba fangosa. Gli occhi rimasero fissi sui gerani che spiccavano davanti alla lapide come piccole sfere infuocate, tanti tramonti ricchi di speranza.
Non mi mossi.
Credevo si trattasse di un passante che stesse cercando la tomba del proprio caro, invece si fermò esattamente accanto a me, chinandosi.
Corrugai le sopracciglia non appena spuntò una mano dalla carnagione bronzea che impugnava un mazzo di crisantemi, le unghie poco curate, i tatuaggi alla base di ogni falange, degli anelli a stampo gotico ad abbellirle le dita. Stranamente, vedendo sbucare una fronte spaziosa e un profilo scolpito nell'apatia, non riuscii a sorprendermi quando capii fosse lei. E nemmeno avrei dovuto quando, qualche tempo prima, mi ero scontrata con Warren. Dovevo ricordare a me stessa che Chestnut Hill era un quartiere davvero minuscolo, e avevo avuto la fortuna di incontrare e conoscere tutti loro proprio lì, all'interno di uno dei tanti piccoli cuori pulsanti di Filadelfia. Sebbene mi fossi sempre impegnata a cambiare strada quando incrociavo qualcuno del gruppo, capii che con la fatalità c'era ben poco da fare.
Mi immobilizzai, mentre sdraiava il mazzo sul terreno.
Perché sei qui?
Dopodiché, si sollevò dalla posizione chinata e rimase ferma a contemplare la lapide. Sostò pochi minuti che, per me, sembrarono durare un'eternità. Non sapevo come comportarmi, se appellarmi al silenzio, se dirle qualcosa. Intanto, quei due o tre passanti che giravano per il cimitero del Santo Sepolcro avevano deciso di tornarsene a casa.
Proprio tu che non sopporti questo posto... perché?
Non feci in tempo a realizzare quel pensiero che cominciò ad allontanarsi, i sandali scuri che lasciavano orme scavate nell'erba. Voltandomi in maniera impercettibile, la vidi tastarsi le tasche posteriori dei pantaloncini e tirare fuori un pacchetto di sigarette. Si era tagliata i capelli; adesso una timida corrente d'aria le smuoveva un taglio deliziosamente ondulato, che le arrivava al collo.
Dalle spalle scoperte, sotto la nuca, spuntava un'Ankh tatuato.
Perché?
«Gwenda.»
Rendermi conto che ero stata io richiese tempo. Lei, tuttavia, non si voltò, né parlò. Rimase immobile. Tra di noi, solo un vento tiepido e delle parole che venivano seppellite nel silenzio.
Incespicai nei miei stessi pensieri. Aprii e chiusi la bocca.
Infine mormorai un: «Grazie».
Non rispose; Gwenda attese un po', poi riprese a camminare.

"Possiamo parlare?"
Doppia spunta.
"Per favore..."
Doppia spunta.
"Liv."
Doppia spunta.
Mi sentivo ridicola a contare quella colonna di messaggi che trasudava disperazione. Secondo Telegram, l'ultima volta che Olivia era entrata nella piattaforma era stato "di recente". Erano giorni che quella dicitura si era fissata sotto al suo nome. Avevo capito che aveva tolto l'ultimo accesso; non voleva essere controllata, non voleva parlarmi. Non ancora. E non ero sicura l'avrebbe fatto tanto alla svelta.
Spensi la schermata del cellulare, con un sospiro.
Cindy e Leonard, davanti a me, cercavano di disegnare.
Avrei dovuto controllarli, come le maestre quando si aggiravano tra i banchi durante l'ora della verifica, eppure non avevo testa per stargli dietro; se avessero iniziato a urlarsi contro, probabilmente non avrei avuto nemmeno le forze per riuscire a separarli. La concentrazione era compromessa da ciò che, negli ultimi giorni, respiravo in casa; Olivia mi evitava, se cercavo di fermarla in corridoio fingeva di non ascoltarmi, la mattina filava a lavoro senza degnarmi di uno sguardo ma salutando affettuosamente i miei genitori, quasi lo facesse di proposito. E loro, della cena, avevano saputo lo stretto necessario, condito da qualche leggera bugia: una serata tranquilla, i bambini che litigavano, i fratelli Holmberg contenti di aver conosciuto mia sorella.
Mia madre aveva pure notato il graffio il giorno seguente, quando provavo a coprirlo con del fondotinta seguendo dei tutorial che avevo scovato su Facebook. Non l'avevo mai guardata negli occhi mentre le raccontavo di un'azzuffata piuttosto violenta avvenuta tra Cindy e Leonard, e che provando a dividerli, erroneamente, uno di loro mi aveva graffiata. Lei si era allarmata all'istante, suggerendomi di segnalarlo al padre, ma io l'avevo tranquillizzata. Non era stato niente.
Non è niente, è capitato, poi passa, non voglio essere un peso.
Riaccesi la schermata sperando in una notifica, un segno.
Non era apparso ancora nulla. Non fare così.
«Cosa fai?»
Cindy, in piedi, fissava ciò che avevo tra le mani.
Riposi il telefono in tasca. «Nulla, controllavo l'ora.»
«Zio Des dice che le babysitter non devono stare al telefono.»
«Sì, infatti ha ragione. Perdonami.»
«Ti annoi?»
«No, no!» Cercai di stirare un sorriso. «In realtà aspettavo i vostri disegni, stavo controllando quanto ci stavate impiegando. Siete lenti.»
«Io s-s-sto fi-f-finendo!» esclamò Leonard, la faccia sul foglio.
«Allora sei in vantaggio. E mi raccomando: non uscite dai bordi, capito?» Leonard si fermò subito, studiò il suo lavoro, e poi batté entrambe le mani sulla testa nell'angoscia più profonda. Trattenendo una risata, mi rivolsi a Cindy. «Dai, perché non continui anche tu?»
Si sedette sul lettino, vicina a me, e scrollò le spalle. «Tanto Leo è lento anche nel disegno. Il mio lo finisco in cinque minuti se voglio.»
«Vero, dimenticavo che sei un portento.»
«La maestra ha detto che sono la migliore.»
«Allora dimostra che sei la migliore anche questa volta.» Le feci cenno in direzione del tavolino quadrato, dov'era chinato Leonard. «Altrimenti la corona sarò costretta a cederla al tuo caro fratellino.»
«Impossibile. Perché prima vedrà quello che ha fatto.»
Osservai Leonard; si era rimesso a fissare il foglio.
«Poi controllerà il disegno all'infinito.»
Strinse le palpebre, avvicinando l'opera agli occhiali.
«E poi vedrà che fa talmente schifo da non volerlo più consegnare.»
E infatti, un'altra volta, Leonard si infilò le mani tra i capelli.
Non avrei dovuto, ma mi scappò da ridere. «Lo controlli troppo.»
«Lo conosco.» Scrollò le spalle, poi mi guardò. «Sei triste?»
Quella domanda fu talmente repentina che dovetti assimilarla a fondo prima di poter rispondere. Osservando Cindy non vidi traccia di derisione, solo infantile curiosità, di chi sta attendendo una storia.
«Tranquilla, non sono triste. Sono solo un po' stanca.»
«Mmh, ok...» Strinse le labbra, riflettendo, gli occhi scuri nei miei. «È perché tua sorella ha detto che non siete davvero sorelle, vero?»
«Cosa?» Non capii perché mi stessi agitando. «Ma no, non è...»
«Perché non siete vere sorelle? Perché hai una cicogna diversa?»
«Vedi, è complicato.» Girai gli anelli attorno al pollice. «Quando i miei genitori mi avevano adottata, loro avevano già una figlia: Olivia.»
«E perché ti hanno adottata se avevano già Olivia?»
«Gli piaceva l'idea che ci fosse qualcun altro insieme a lei.»
«Quindi siete sorelle lo stesso?»
«Già.»
«E allora perché ha detto che non lo siete?» insistette.
«Beh, conta che io sono una sorella acquisita. Non abbiamo nessun genitore in comune, quindi lo siamo ma...» Mi si serrò la gola nel dover terminare la frase, la stessa che Olivia aveva pronunciato con una leggerezza allucinante. «Lo siamo ma non lo siamo davvero.»
S'imbronciò, abbassando le sopracciglia e tramutando l'espressione in una pregna di confusione. «Zio Des e papà hanno la stessa mamma, i papà sono diversi... Però non hanno mai detto di essere mezzi fratelli. Cioè, dicono di essere veri fratelli perché si vogliono bene.»
Assottigliò le labbra in una smorfia che rasentava l'indifferenza, io schiusi la bocca; non seppi come ribattere a una bambina di otto anni.
Contemporaneamente, dal salone udii sbattere una porta.
Si diffuse il tipico tintinnio di un mazzo di chiavi e un lieve brusio, due voci che si sovrapponevano. Discutevano. Cindy e Leonard, nello stesso momento, scattarono in piedi, gli occhi due stelle di felicità. «Papà!» urlarono in coro, prima di fiondarsi fuori dalla stanza. Continuarono a ripeterlo anche quando l'eco delle scarpe si arrestò.
Mi feci coraggio e, recuperando la borsa, li raggiunsi.
Mi si aprì l'immagine vivace di Gregg che teneva in braccio Leonard mentre gli schioccava un bacio sulla guancia, e Cindy che gli abbracciava la vita. Dietro di lui, suo fratello; stava riponendo il telefono in tasca. A quanto pareva, erano tornati nello stesso momento.
D'istinto, mi sistemai i capelli in modo tale che nascondessero il graffio. Desmond issò lo sguardo su di me, da oltre la spalla di Gregg, e io fuggii da quell'attenzione, aderendo una ciocca alla guancia.
«Papà, indovina che giorno è sabato?» domandò Cindy, euforica.
«Un giorno qualunque, ovviamente.»
«Papà!»
Mise giù Leonard e scombinò i capelli all'altra, provocandole un risolino divertito. «Un giorno qualunque molto, molto speciale.»
Lei mostrò i denti. «Quindi andiamo al Jolly Roger, vero?»
Gregg continuò ad accarezzarle il capo e, gradualmente, l'espressione stanca ma contenta divenne stanca e basta. L'entusiasmo che gli aveva acceso gli occhi azzurri e con cui aveva accolto i figli scemò in un battito di ciglia. Inclinò la testa all'indietro, si strofinò le palpebre. Desmond, dietro, aveva l'aria di chi aveva capito come avrebbe continuato; infatti, alzò gli occhi al cielo, a braccia conserte.
Lei indurì lo sguardo. «Papà.»
«Ascolta...»
Gli lasciò la manica. «Me l'avevi promesso!»
«Lo so, ma...» Cercò aiuto in suo fratello. «Spiegaglielo tu.»
«Non è compito mio, e poi ha ragione: gliel'avevi promesso.»
«Grazie» rispose secco, poi si chinò sui talloni e la guardò negli occhi. «Cindy, tesoro, cerca di capirmi... In ospedale potrebbero avere bisogno anche di me, non posso allontanarmi da qui se ci fosse un'emergenza. Però possiamo festeggiare tutti insieme la sera e...»
«No, io voglio andare al Jolly Roger!»
Si massaggiò la faccia, sconfortato, e con cautela tentò a riferirle: «Quel giorno sono reperibile e non sono coperto per un'assenza... Però la sera ci sono, potremmo andare a mangiare fuori, oppure...»
Si allontanò a muso duro, i pugni stretti e gli occhi divenuti affilati, lucidi. Ma non pianse, si trattenne con l'aria solenne di un'adulta.
Afferrò la mano dello zio. «Allora vieni tu, vero?»
Desmond osservò Gregg, ma vedendolo sospirare, abbandonò l'espressione di biasimo che gli aveva contratto i lineamenti. Probabilmente capì che c'era poco che potesse fare. Quindi le sorrise.
«Certo che vengo.»
Dopodiché mi raggiunse, prendendomi le mani. «Vieni anche tu.»
Sorpresa, sollevai le sopracciglia, balbettando: «Ah... io?»
«Sì, tu.»
«Cindy, lascia perdere la babysitter, quel giorno si riposerà» disse Gregg, afferrandola da una spalla. Ma, con rabbia, si scrollò la mano.
Lei girò la testa, guardando Desmond. «Può venire? È triste.»
Non seppi come reagire, a quale giustificazione ricorrere senza sembrare brusca. Perché in quel momento, in testa, si affastellarono tutte le possibili ripercussioni che avrebbero potuto esserci se avessi acconsentito alla proposta. E tutte le opzioni portavano a mia sorella.
Nel panico alzai lo sguardo su Desmond. Aveva fatto la stessa cosa. Tuttavia, allargò gli occhi per un secondo, a mo' di avvertimento silente, e, con la testa, mi fece cenno di uscire dalla porta d'ingresso.
Si rivolse a sua nipote. «Ora ci parlo io, ok?»
Prima di tornarsene in camera sua, seguita da Leonard, Cindy esultò e fece la linguaccia a suo padre. Gregg poté solo sospirare.
Una volta in veranda, la bella stagione mi avvolse come una coperta calda. Incrociai le braccia al petto, nonostante l'alta temperatura. Desmond, intanto, si appostò sui gradini, sedendocisi.
Diede un secco colpo di tosse e si tastò le tasche a vuoto.
«Ottimo, non posso nemmeno contare sulla nicotina. E vabbè.» Piegò le ginocchia per poggiarci i gomiti e osservò la strada dinanzi. Qualche ragazzino la stava attraversando in skateboard. «Facciamo così, partiamo da questo: sono uno stronzo. E lo so, so che non ha fatto altro che pensarlo. Sa quante volte ho starnutito negli ultimi giorni?»
«Non l'ho mai pensato.»
«Ma sì che l'ha pensato, lo pensano tutti. Solo che lei è troppo educata per ammetterlo a voce.» Alzò lo sguardo, l'espressione non del tutto distesa a dispetto di ciò che aveva pronunciato. Eppure, non mi guardò negli occhi; l'attenzione scivolò a destra, sulla guancia che avevo maldestramente provato a nascondere con i capelli. In automatico, cercai di riportare la ciocca sulla gota, appiccicandocela. «Mi dispiace per come sono andate a finire le cose e per... quello.»
Mi guardai le scarpe. «Non è niente, e non deve dispiacersi.»
«Il fatto è che non potevo starmene zitto mentre le...»
«Signor Holmberg» lo interruppi, chiudendo gli occhi per un attimo. «Vorrei non parlare più di quella sera. La prego, basta così.»
Aprì bocca, la richiuse. Annuì, tornando a scrutare la strada.
«Allora le chiedo: mi dà l'opportunità di scusarmi?»
«Le ripeto che non c'è nulla di cui debba...»
«Ok, cambio modalità, sarò più diretto: venga al compleanno di Cindy.» Intrecciò le dita, fissò l'asfalto sotto ai suoi piedi. «Sembrerà una patetica tattica per provare a persuaderla, e sottolineo che non lo è, ma se dirà di no a quella bambina, riceverà soltanto l'ennesima delusione. E suo padre gliene ha appena fornita una pesante.»
Assottigliai le labbra. «Non sono una bella compagnia.»
«Per Cindy evidentemente lo è, se l'ha invitata. Mi creda, non ha un carattere facile da gestire, ed è molto selettiva, con chiunque.» Si strofinò il mento, con fare assorto. «Non ha amici su cui contare per questo. Ma non voglio che le faccia pietà, quindi se non se la sente di venire rispetterò la sua scelta e vedrò di inventarmi qualcosa che...»
«Io accetterei volentieri, ma se mia sorella venisse a sapere con chi sto passando il mio tempo all'infuori del lavoro, litigheremmo ancora. Già una volta mi è bastato, e non voglio che ricapiti di nuovo.»
Faticai a mantenere un tono che non subisse tremolii, faticai anche a mantenere un contatto visivo saldo con i suoi occhi, ma volevo che capisse che mi trovavo in una posizione già abbastanza problematica.
E forse capì, anche se impiegò un po' prima di annuire e alzarsi.
Appena impugnò la maniglia, gli riferii: «Non ce l'ho con lei».
Rimase fermo, il pollice sfregò l'impugnatura. «Dovrebbe, invece.» Ruotò appena il viso. «Pensi alla proposta. A Cindy farebbe piacere.»
ANGOLO AUTRICE
Buongiorno, nightingales! 🕊️
Capitolino di passaggio, ma estremamente importante... perché andiamo a volgere lo sguardo a uno spiraglio della vita di Ophelia che, fino ad ora, non abbiamo ancora parlato: le sue origini. Con il gioco del dare e l'avere, siamo solo andati a scavare soltanto la superficie del suo "prima", ma andando avanti con la storia si andranno a capire tanti altri piccoli dettagli.
Nel flashback andiamo innanzitutto a dare una spiegazione doverosa al suo attaccamento al mondo dei senzatetto (immagino ve lo sarete chiesti dal momento che li avevo introdotti), quindi, diciamo, che tutto è partito quando era piccola. E non appena è cresciuta, ha iniziato a fare volontariato presso uno dei tanti rifugi di Filadelfia.
Fun fuct: al quarto anno di liceo la nostra scuola aderì a un progetto che vedeva come protagonisti questo mondo. Avevamo fatto volontariato in una mensa per i poveri. ✨
Detto ciò, tornando al tempo presente, vediamo Ophelia parlare con una lapide. Non viene mai nominato il nome, ma l'identità della persona a cui va a far visita non è difficile da indovinare. 🖤 E proprio lì che appare, senza che possa aspettarselo, un membro del suo vecchio gruppo di amici: Gwenda. Chissà perché era lì, a rendere omaggio a questa persona. 👀
Infine... il compleanno di Cindy. (💀)
Curiosità:

▪️ Il pickleball è uno sport di racchetta, che richiama le tecniche e le regole del tennis, del badminton e del tennistavolo
Questions:
▪️ Chi sarà mai questa persona che Ophelia è andata a trovare?
▪️ Come mai Gwenda si è fatta vedere, proprio davanti alla lapide di questa persona che è andata a trovare Ophelia?
▪️ Che avete pensato della breve chiacchierata Judy e Ophelia junior? E quella fra Ophelia dei tempi odierni con Cindy?
▪️ Secondo voi accetterà l'invito, nonostante la situazione con sua sorella? Cosa pensate del comportamento di entrambe le sorelle?
▪️ Avete mai aderito a qualche progetto di volontariato che ha visto in prima persona la questione dei senzatetto? Se vi va, raccontatela pure. Mi piacerebbe sentire anche la vostra. 🖤
Noi ci vediamo... ok, non dico date per paura di non rispettarle, perché come per la cena, anche il prossimo capitolo è da dividere in due AHAHAHAHAH mi sento male al solo pensiero. Chissà che cosa accadrà...
Curiosi? 💀 See ya soon! 🕊️
Playlist:
Cosmic Dancer - T. REX (prima parte)
Seastroke - Wyldest (seconda parte)
Trouble - Cage The Elephant (terza parte)
Instagram: The_blackcatshadow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro