50 ~Sono esattamente come te~
Una volta scese dall'aereo, mia madre aveva preso la mia valigia con risolutezza, quasi mi volesse dire che non aveva intenzione di aiutarmi a camminare questa volta. Sembrava esserci rimasta davvero male per la mia battuta insolente fatta durante il volo. Per questo mi aggrappai con fermezza alle stampelle con Sveva che, in maniera premurosa, mi camminava accanto nel caso dovesse servirmi aiuto per scendere o salire le scale.
Visto che mia madre era lontana ne approfittai per affrontare un discorso spinoso: «Lia sa del video?», chiesi a Sveva.
Lei rimase per un secondo interdetta, come se stesse ragionando se fosse opportuno dirmi la verità: «tua madre mi ha detto di non dirtelo ma ormai mi conosci, se penso che una cosa sia giusta, la faccio. Valeria ha parlato con i genitori di Lia del video quindi immagino che lei a quest'ora sappia tutto».
«E gli altri lo sanno?».
«Io l'ho solamente accennato a Samuele», mi rispose alzando impercettibilmente le spalle.
«A proposito», le dissi fermandomi un attimo per riprendere fiato, visto che mi dovevo ancora abituare a camminare per tanto tempo con le stampelle, «non dirgli l'ora precisa in cui arriviamo a casa. Per favore».
Un sorriso fuggevole le si dipinse sul volto prima di acconsentire.
Una di fianco all'altra entrammo nel caos infernale dell'aeroporto di Fiumicino, con il vociare indistinto della folla, le luci al neon dei negozi e gli annunci lampeggianti che comparivano a ripetizione sugli schermi informativi. Non appena uscimmo sulla strada, la prima cosa che notai di diverso fu l'aria: era densa e mi sembrava di fare più fatica a respirare e poi, il sole, sembrava meno luminoso, come se fosse ricoperto da una patina opaca che non gli permetteva di brillare come avrebbe potuto. Non facemmo in tempo a guardarci intorno che un uomo sulla sessantina ci chiese se avessimo bisogno di un taxi, mia madre annuì e si avvicinò con velocità verso una Toyota bianca.
Dopo averci aiutato a caricare le valigie nel portabagagli, il tassista, un uomo dai lunghi capelli grigi arruffati e tenuti indietro con un cerchietto, ci fece accomodare in macchina e si mise alla guida per poi iniziare un lungo monologo. Parlò del traffico di Roma, della manifestazione sportiva che si era svolta qualche giorno fa vicino al Colosseo, della temperatura che quest'anno era stata molto alta e della siccità. Nessuno lo ascoltava e, solo mia madre, annuiva in modo educato leggermente infastidita dal modo esagerato di gesticolare dell'uomo che, poco prima di accostarsi di fronte casa di Sveva, aveva iniziato a raccontarci di un fantomatico terreno che lo zio gli aveva lasciato in eredità un mese fa.
Sveva abitava in un palazzo antico situato non lontano dalla basilica di San Pietro, era una struttura imponente con un enorme portone in legno dall'aria vetusta adornato con delle maniglie in oro.
«Tu vivi qui?», domandai sporgendomi dal finestrino del taxi per guardare meglio.
«Casa dolce casa», sospirò Sveva rimettendosi gli occhiali da sole che aveva incastrato nello scollo della canottiera.
Scese con agilità dalla macchina nonostante i suoi sandali con zeppa, il tassista le consegnò la valigia e lei, poco prima di voltarsi per raggiungere il portone di casa, mi guardò dal finestrino abbassato e disse: «se per caso un giorno avessi voglia di assaggiare qualche pasticcino fatto in casa la mia porta è aperta».
La sue parole mi sorpresero, Sveva stava palesando il suo più grande problema: la solitudine. Spesso le persone sincere e schiette come lei tendono a farsi terra bruciata intorno senza dare a vedere quanto in realtà soffrano.
«Volentieri! Se poi c'è la cheesecake sono già lì!», esclamai con entusiasmo e con una felicità leggermente artefatta, considerata la mia condizione, ma cercavo di ringraziarla con i fatti e non solo con le parole.
Lei per tutta risposta si sfilò uno dei tanti braccialetti d'acciaio rosa e me lo porse: «da qualche parte ho letto che porta sfortuna avere un numero di braccialetti pari. In questo modo ne ho undici!».
«Mai sentita questa cosa», dissi perplessa infilandomi il braccialetto al polso sinistro, «dove l'hai letta?».
La sua risposta fu un sorriso falsamente ingenuo corredato da un'alzata di spalle.
Io e mamma facemmo appena in tempo a salutarla con la mano che il taxi ripartì sgommando tra le strade trafficate di Roma.
Il tassista continuò con il suo sproloquio accompagnato dall'incessante gesticolare, questa volta non capii neanche di cosa stesse parlando perché ero troppo presa a osservare i familiari palazzi romani dall'aria vissuta, i numerosi bar pullulati da persone che bevevano bevande fresche o si gustavano gelati artigianali, i motorini che si intrufolavano tra le macchine per sgusciare via dalle code interminabili del traffico e le biciclette che si muovevano a filo marciapiede.
Stavo tornando a casa, e non pensavo che mi avrebbe fatto un effetto così drastico. Avevo la tachicardia. L'ansia mi fece iniziare a sudare freddo, con le mani cercavo di sventolarmi il viso accaldato.
Tornare a casa voleva dire affrontare il mio infortunio, capire come sarebbe cambiata la mia vita da quel momento in poi. Il picco d'angoscia lo raggiunsi quando il taxi si fermò esattamente davanti l'ingresso del mio palazzo, scesi con fatica sentendo del fastidio al fianco e con le gambe molli per la tensione. Il tassista fu talmente gentile da portarci le valigie e accompagnarci fino alla porta di casa, io mi sostenevo grazie alle stampelle e mia madre frugava nel portafoglio per cercare una banconota da lasciare all'uomo, in modo da liquidarlo in fretta e salvarci da un altro probabile sermone inutile.
Si dice che ogni casa ha un odore ben definito eppure, ognuno di noi, non sa riconoscere quello della propria fino a che non la lascia per qualche giorno. Non ci avevo mai pensato ma, dopo essere stata a lungo lontana, trovai la conferma a questa teoria. Non appena varcai la soglia di casa, infatti, mi investì un intenso profumo di cannella, mia madre era solita bruciare un incenso al giorno in salotto e, le pareti, si erano impregnate di quella profumazione piccante e tagliente. Ci ero talmente abituata che non avevo mai colto quanto fosse intensa.
Mia madre, senza dire una parola, si tolse dalla spalla la borsa a tracolla, poggiò il mazzo di chiavi nel portaoggetti posizionato sul camino del salone e si ritirò subito in camera sua.
Io restai per un momento lì in piedi, lo sguardo che guizzò senza volerlo verso la poltrona di papà e lo stomaco che mi rispose con una morsa stretta.
Non mi sarei mai abituata alla sua assenza, questa casa avrebbe sempre evocato il suo ricordo e quella poltrona vuota, su cui lui era solito leggere un libro prima di andare a dormire, mi avrebbe sempre tormentato facendomi ricordare che lui non sarebbe mai più tornato.
Il colpo di grazia, però, me lo diede la mia stanza.
Non appena aprii la porta guardai subito la "mensola delle meraviglie", come era solita chiamarla papà, lì sopra avevo poggiato gli oggetti che rappresentavano i miei piccoli traguardi, dalla prima medaglia di bambina all'ultima coppa vinta a Jesolo poco prima della partenza per le Olimpiadi.
Ora avrei potuto aggiungere la medaglia d'oro di Rio.
Forse poteva essere l'ultimo gradito ospite sulla mensola delle meraviglie.
Questo pensiero mi tolse il respiro, era curioso come, gli oggetti che prima ti infondevano grinta e stima di te stessa, adesso sembravano mille occhi famelici che, in modo sadico, ti ricordavano che la ragazza che li aveva guadagnati con fatica non c'era più. Ora c'era solo un grande punto di domanda che non rappresentava altro che l'ignoto a cui sarei andata incontro da lì in poi.
Mi distesi sul letto, occhi al soffitto e mani poggiate dietro la nuca, mi colse subito un doloroso fastidio alla ferita. Ero già talmente provata da tutte queste sensazioni contrastanti che non volevo dover soffrire anche fisicamente così, con uno sforzo non indifferente, mi rimisi seduta sul letto e inforcai di nuovo una stampella, giusto per sicurezza. Attraversai il corridoio per raggiungere la porta della stanza di mia madre e chiederle un antidolorifico, provai ad abbassare la maniglia ma si era chiusa a chiave.
Bussai piano, nessuna risposta.
«Mamma mi fa male il fianco, dove sono gli antidolorifici?», le domandai alzando la voce.
«Controlla nella mia borsa, è poggiata vicino l'attaccapanni», rispose lei in modo aspro.
Mi diressi verso l'ingresso, cercai di far finta di non vedere il cappotto blu di papà ancora lì appeso, e presi tra le mani la tracolla di mia madre. Era abituata ad andare in giro con delle borse enorme simili a piccole valigie e dentro vi era di tutto, non mi sarei stupita se avessi iniziato a tirar fuori oggetti improbabili come faceva Mary Poppins. Svuotai il contenuto su un tavolino lì vicino, c'era il portafogli, una piccola pochette con mascara, matita e rossetto, essenziali per ritoccarsi un poco il trucco in qualsiasi occasione, un pacchetto di fazzoletti e una penna ma, delle medicine, non vi era l'ombra. Poi notai una zip laterale con un leggero rigonfiamento, l'aprii e trovai ciò che stavo cercando, la mia mano però si soffermò anche su un altro oggetto, lo tirai fuori ma mi cadde dalle mani.
Non potevo credere ai miei occhi. Era un piccolo blocco da cui si staccavano dei bigliettini lucidi e di colore rosa, esattamente uguali ai foglietti delle minacce, non poteva essere un caso.
«Mamma », gridai fuori di me.
Non ottenni risposta, «mamma», ripetei in modo talmente rabbioso da non riconoscere la mia stessa voce.
A quel punto sentii la serratura della sua stanza scattare e la vidi uscire di corsa: «ti senti male?», appariva veramente preoccupata.
Io presi quel piccolo blocco da terra e glielo mostrai: «questo che diavolo sarebbe?».
Lei non rispose, adesso sembrava il ritratto del dispiacere, abbassò gli occhi sul tappeto persiano che ricopriva gran parte del parquet.
«Io non ci credo, sei stata tu!», sospirai senza sapere cos'altro fare e con la sensazione che, di lì a qualche minuto, sarei svenuta.
«Giusy», disse lei con un filo di voce avvicinandosi a me, «l'ho fatto per il tuo bene».
«Per il mio b-bene?», balbettai per la sua risposta surreale, «tu minacci tua figlia per il suo bene? È questo che vuoi dirmi?».
«Samuele ti stava facendo perdere di vista il tuo obiettivo».
«Che cosa?».
«Hai capito bene, non eri più concentrata e ho dovuto trovare una soluzione».
«Hai dovuto?», le domandai sgomenta, «e tu credevi che se avessi ricevuto degli stupidi foglietti avrei smesso di pensare a Samuele?».
«Ho sperato».
Ci fu un silenzio tagliente.
«E il body», puntualizzai con la voce spezzata dalla rabbia e dall'incredulità, «a quel punto cosa serviva farlo sparire?».
«Non lo so, ero arrabbiata perché tu avevi ancora lui per la testa e...».
«Ti sembra una motivazione valida? Sul serio?».
«Io...», mormorò mia madre continuando a tenere gli occhi fissi sul pavimento per la vergogna, la sua pelle stava assumendo un colorito pallido, come se fosse in procinto di sentirsi male anche lei.
«Ma quanti anni hai?», sibilai io, «ero già incredula che potesse averlo fatto Lia, ma almeno lei ha sedici anni... tu ne hai quarantotto».
«Non volevo che facessi la mia stessa fine», disse titubante per poi guardarmi negli occhi e aggiungere: «ecco tutto».
«Tu ti sei infortuna per aver messo male il piede nell'uscita dalle parallele. Cosa diavolo c'entra!».
«No».
«Sì, ho visto il video delle Olimpiadi di Los Angeles».
«Ma non è quella la causa, te lo sei mai chiesta? Io non sbagliavo mai», proferì con decisione pavoneggiandosi anche in quest'occasione.
Detestavo la superbia senza limiti di mia madre e la sua incapacità nel dosarla.
«Sei umana, non dimenticarlo», le rammentai.
«Il problema è che erano due mesi che non mi allenavo come avrei dovuto, e il risultato è stato questo», disse lei alzandosi la gonna color panna e mostrandomi l'evidente cicatrice sul ginocchio che non si era mai sbiadita con gli anni.
«Smettila di cercare inutili giustificazioni alla tua cattiveria».
«Mi ero innamorata Giusy, e non riuscivo a non pensare a tuo padre, durante gli allenamenti e fuori dalla palestra».
«Impossibile. Papà lo hai conosciuto quando io avevo cinque anni», le feci notare scuotendo la testa.
«Il tuo vero padre», concluse lei con estrema freddezza.
Ero già fuori di me dalla rabbia ma quest'affermazione fu la goccia che fece traboccare il vaso, mi avvicinai a lei e le puntai il dito contro mentre dissi a denti stretti: «non ti azzardare mai più a chiamare padre l'essere che mi ha concepita, sono stata chiara?».
Mia madre aprì la bocca per replicare ma poi si fermò, come se ci avesse ripensato.
Io allargai le braccia esasperata: «non hai nient'altro da aggiungere?».
«Ho solo agito cercando di evitarti il dolore che ho subito io», disse chinando di nuovo la testa verso il basso.
Non si sarebbe mai umiliata nel chiedere scusa, neanche di fronte all'evidenza, neanche se fosse stata una questione di vita o di morte, quelle cinque lettere disposte in quell'ordine erano per lei impronunciabili.
Mia madre continuava a fissare il tappeto a braccia conserte.
A quel punto irritata gridai: «Mamma!».
Lei non rispose e non alzò lo sguardo.
«Guardami maledizione!», strillai sbattendo un piede a terra fino a che lei, finalmente, non si decise a posare i suoi occhi scuri nei miei.
«Sono esattamente come te ora», dissi indicandole il fianco.
«Oh no!», esclamò lei con ritrovato vigore, «tu hai vinto le Olimpiadi, Giusy».
Si avvicinò a me poggiandomi una mano sulla spalla con quel fare materno che non le si addiceva, gli occhi che sembravano brillargli al suono della parola Olimpiadi.
Io la scansai e andai dritta verso la mia stanza zoppicando leggermente, frugai nella mia valigia fino ad estrarre una custodia rigida, l'aprii ed estrassi la medaglia d'oro prima di tornare da mia madre.
«Ti riferisci a questa?», le domandai furente facendo dondolare la medaglia come se fosse un pendolo per ipnosi.
Lei sorrise appena: «vedi? Siamo diverse, tu hai raggiunto il tuo sogno».
Valeria non sarebbe mai cambiata, nonostante mi fossi infortunata in Brasile, continuava a pensare ossessivamente a quel trofeo.
Io osservai la medaglia, il suo colore oro e la sua incisione, eppure adesso non provavo più quella sensazione di beatitudine e gratificazione, mi sembrava un oggetto privo di valore.
Con un gesto istintivo gliela lanciai addosso e lei l'afferrò con prontezza.
«È tua. Io non la voglio più».
«Ma come? Dopo tutti gli sforzi che hai fatto».
«Quella Giusy non esiste più, ficcatelo in testa! Puoi tenertela visto che ci tieni tanto, visto che sei arrivata a minacciarmi per far sì che vincessi».
Ero talmente arrabbiata con lei da non sopportare più di vedere il suo viso ossuto e i suoi occhi neri e freddi. A quel punto raccolsi la borsa che avevo poggiato sul letto e ripresi la mia stampella prima di dirigermi verso la porta d'uscita, avevo bisogno di stare lontano da Valeria.
«Dove vai?», mi chiese mia madre colta alla sprovvista.
«Lontano da te», sbuffai.
«Ma nelle tue condizioni è pericoloso».
«È più pericoloso che io resti nello stesso tuo appartamento in questo momento», affermai minacciosa.
Non mi avrebbe potuto fermare in nessun caso, così le diedi le spalle e aprii la porta di casa.
«Aspetta un attimo», disse lei facendo una piccola corsa in camera sua, sentii la zip della valigia che si apriva e poi dei rumori indistinti, come qualcosa che veniva buttato a terra, quando tornò aveva nelle mani il mio cellulare.
«Se ti dovesse succedere qualcosa...», mormorò lei talmente piano che faticai a sentire le sue parole, probabilmente smorzate dalla vergogna.
Io le tolsi il cellulare dalle mani con tanta rabbia che le graffiai la pelle, poi la guardai in cagnesco dritta negli occhi: «hai finto per tutto questo tempo di aver perso il mio cellulare? Con me hai chiuso».
Uscii sbattendo la porta di casa talmente forte che la dirimpettaia si affacciò incuriosita.
Non avrei mai pensato di poter arrivare a questo punto, incredula e amareggiata come mai mi ero sentita, mi incamminai per raggiungere l'unica persona che mi avrebbe potuta capire.
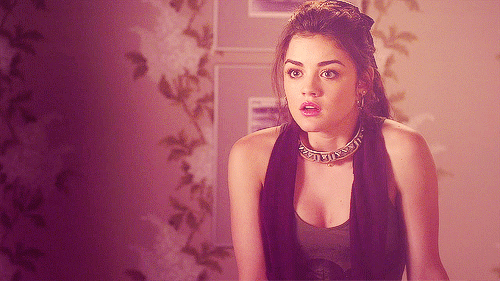
SPAZIO AUTRICE:
Vi aspettavate il colpo di scena?
Da chi andrà Giusy?❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro