07. Between these walls
Canzone nei media:
My house - PVRIS

"Non dar retta ai tuoi occhi
e non credere a ciò che vedi:
gli occhivedono soltanto ciò che è limitato."
(Richard Bach)
❇
Poggiata con la schiena alla parete del corridoio, osservavo la figura slanciata e spigolosa di Aušrius confabulare con quello che – quando l'avevamo visto avvicinarsi lento e impettito – mi aveva detto di essere il maggiordomo. Si chiamava Håvard ed era un uomo sulla settantina con radi capelli grigi e un faccione dalle gote cadenti. Potevo sentire la sua voce profonda rivolgersi ad Aušrius con tono gentile, porgli domande su di me per, a detta sua, potersi interessare al meglio ai miei bisogni. La cosa m'innervosiva, peggiorando il mio umore: Håvard avrebbe potuto guardarmi negli occhi e chiedere a me, quelle informazioni, non fare come non ci fossi. Non necessitavo né di una balia né di un altro Richard.
Sbuffai, digrignando i denti, e distolsi lo sguardo, in attesa che mi concedessero la propria attenzione. Forse mi udirono, perché la voce nasale di Aušrius si fece alta mentre diceva: «Perfetto, Håvard, grazie. E non temere, Zoë è una persona ragionevole, secondo me andrete d'accordo.»
Gli rivolsi un'occhiata omicida nello stesso momento in cui lui posava gli occhi acquamarina nei miei, un'espressione esaustiva dipinta in volto. Non fu complesso cosa volesse comunicarmi.
«Ne sono sicuro anch'io, signorino» rispose il maggiordomo, con una voce baritonale ma tremante. Il suo atteggiamento era calmo, più simile a quello di Aušrius che di Victor, e cercai di comportarmi di conseguenza. Si attirano più mosche con il miele che con l'aceto.
«Andiamo, allora?» intervenni, schiodandomi dalla parete con un rimbalzo.
«Certo» replicò Aušrius. «Purtroppo io mi devo congedare.» Si avvicinò a me lentamente, mantenendo lo sguardo nel mio. Quando fummo a pochi centimetri di distanza allungò la mano destra verso di me. «È stato un piacere, Zoë.»
«Grazie» mormorai, stringendo la sua mano. Cercai di ignorare il sangue secco sulle sue unghie.
Mi studiò in silenzio per qualche istante. «Ora ti lascio alle cure di Håvard, a stasera» detto questo mi sorrise, fece un cenno del capo a entrambi e voltandoci le spalle si allontanò in fretta nella direzione da cui eravamo venuti.
Rimasti soli, fra me e il maggiordomo calò il silenzio, fino a quando lui non si schiarì la gola e fece un inchino. «Il mio nome è Håvard Mortensen, signorina.» Aveva un accento del nord, svedese a giudicare dal nome, e quando si chinò in avanti per fare un inchino vidi la sua fatica nel farlo.
«Non inchinarti» mi affrettai a dire, «e non chiamarmi "signorina", per favore. Chiamami solo Zoë.» Mi costrinsi a sorridergli e lo raggiunsi.
«Mi segua, le mostro la strada per il bagno.» Håvard mi diede le spalle e si avviò, avanzando lungo il corridoio scarsamente illuminato a un'andatura sostenuta.
Sulla parete alla nostra sinistra si stagliava una serie di finestre dalla forma squadrata e dal vetro smerigliato, con delle inferriate nere nella parte interna. Ai loro piedi c'era una lunga panca di legno accorpata al muro. Sulla destra, invece, c'era una parete continua su cui ogni tanto spuntavano delle porte chiuse. La voglia di afferrare la maniglia per scoprire cosa vi si celasse dentro mi bruciava sotto alla pelle, e dovetti stringere le mani a pugno per impedirmi di allungare il braccio.
Le voci erano silenziose, come se la lontananza da quel Victor avesse in qualche modo calmato il loro rumore. Una parte della mia testa non smetteva di ripensare a lui, a come si era palesato nella stanza dal nulla o alla strana maniera in cui era rimasto a fissarmi nello studio. Avevo voglia, per qualche assurda ragione che ancora non riuscivo a comprendere, di rivederlo, e ora che avevo mangiato e il mal di testa era sceso il tarlo del dubbio si era fatto più vivo che mai. Continuavo a sentire che qualcosa non tornava, qualcosa d'importante che avrei dovuto ricordare, ma nella mia testa c'era un vuoto che non ero in grado di colmare.
Avevo pensato che si trattasse della somiglianza della voce e degli occhi di Victor con quelli dell'Uomo dell'Incubo, ma mi ero presto resa conto che la cosa non reggeva. Insomma, non aveva senso: come avrei potuto sognare il mio rapitore prima che questi mi rapisse? Non ero una sensitiva, nonostante quello che nutrivo nei confronti di entrambi fosse simile, se non identico. Quindi doveva trattarsi di qualcos'altro, ma cosa?
Mi accorsi improvvisamente che Håvard stava parlando e mi diedi un ceffone mentale per essermi distratta. «Scusami, Håvard, potresti ripetere? Non ho capito.»
«Ho detto che purtroppo non potrò occuparmi costantemente di lei, sign... Zoë. Il padrone Dimitar richiede l'impiego del mio tempo in faccende di – mi perdoni se mi esprimo in modo tanto scortese – ben altra importanza. Pertanto, sotto suo diretto ordine, la vostra cura verrà alternata fra me e altre due domestiche molto gentili che lavorano e vivono qui da qualche anno.»
Rimasi perplessa. Padrone?
«Non preoccuparti, Håvard. Non dovrei nemmeno trovarmi qui, perciò chi si occuperà di procurarmi gli asciugamani è l'ultimo dei miei pensieri.»
«C'è un motivo ben preciso se si trova qui, Zoë.» Camminava tenendo la mano sinistra poggiata dietro la schiena e il braccio destro davanti al ventre. «Purtroppo, però» continuò, «non sono autorizzato a parlarne. Ma lo saprete presto, sì, forse già questa sera.»
Non dissi nulla e strinsi la mano a pugno, continuando a camminare ma senza prestare attenzione a quel che mi circondava. La mia mente cominciò a divagare. Una parte di me avrebbe voluto che lì con me, al posto di Håvard, ci fosse Victor. Volevo sentire la sua voce sputare parole sprezzanti e deliziarmi del momento in cui avrei stampato la forma della sua faccia nella parete di legno. "Presto lo saprete" aveva detto il maggiordomo, "forse già questa sera". Come se fossero sicuri che io me ne sarei rimasta zitta e buona.
Combatti, Zoë.
No, ascoltami,
devi
restare.
Sussultai, avvertendo un dolore al tendine del pollice destro. Quando guardai in basso vidi che le mie unghie erano sporche di sangue. Per un istante ebbi una vertigine, nell'osservare le gocce che mi macchiavano la pelle, e rimasi con la mano a mezz'aria. Non mi ero resa conto di aver premuto così forte.
Velocemente nascosi l'intero braccio dietro alla schiena, quasi per riflesso automatico, nel momento in cui Håvard si fermò dinnanzi a una porta chiusa e si voltava verso di me, un sorriso dipinto in volto. «Ogni asciugamano e prodotto che potrebbe servirle è già stato disposto, ho incaricato io stesso Áshildur di prepararle la vasca da bagno. Spero che possa rilassarsi un po' in attesa della cena» mi disse con gentilezza. «Mi sembra davvero una brava ragazza. Sono felice che sia finalmente con noi.»
Non gli feci notare di non avere idea di chi fosse questa Áshildur, né gli mostrai quanto fossi seccata da tutta quella storia. Preferii indagare e inscatolare informazioni che sarebbero potute tornare utili in un secondo momento. «E tu un brav'uomo, Håvard. Posso chiederti come sei giunto in questo posto?»
«Oh, sono passati moltissimi anni... a malapena lo ricordo» aggrottò le sopracciglia. «Ormai questa è casa mia e il padrone Dimitar è buono con me.» Un sorriso gli illuminò gli occhi grigi. «Non ho altro luogo che questo, e sono felice così.»
Le sue parole mi provocano una fitta al petto e lo invidiai. Avrei voluto sentirmi anch'io così, tra le mura che condividevo con la mia famiglia a Grimlanes. Il luogo in cui avrei dovuto trovarmi era un altro, lo sapevo, e speravo che prima o poi lo avrei trovato, se fossi stata capace di andarmene da lì con tutte le parti del corpo ancora intatte.
«Allora sono contenta per te, Håvard. Non esiste luogo migliore di casa.» Pronunciare quelle parole fu come deglutire un boccone di cenere.
«La ringrazio. Se mi scusate, però, ora sono costretto a congedarmi. Sono sicuro che ci rivedremo presto.» Io non replicai, non dissi di sperarlo, perché avrei mentito e nella mia vita c'erano già abbastanza bugie. Perciò mi limitai ad annuire e lo osservai allontanarsi con il suo passo incurvato. Quando scomparve, raggiunto il fondo del corridoio e svoltato a destra, gonfiai le guance ed emisi un lunghissimo sbuffo.
Lanciandomi un'occhiata attorno scrutai l'androne. Mi trovavo al primo piano e, tranne che per la disposizione delle porte, era identico a quelli che avevo percorso in compagnia di Aušrius. Quella casa era un vero labirinto.
Sospirai e abbassai di colpo le spalle, allungando la mano verso la maniglia. Fu proprio in quel momento, quando stavo per entrare, che un suono interruppe il silenzio. Fu nulla più che un fruscio, ma in quella quiete attirò la mia attenzione come un frastuono. Proveniva dalla mia destra, nel punto in cui il corridoio faceva un'altra svolta, lontana da me circa sei metri.
Quando girai il capo con un gesto improvviso, feci in tempo a vedere solo un'ombra sulla parete e l'orlo di una gonna azzurra svanire a qualche centimetro da terra. Rimasi immobile sul posto, in attesa di qualche altro suono o di veder comparire qualcuno, ma non accadde nulla.
«La questione si fa sempre più sospetta ogni minuto che passa...» sussurrai a me stessa.
Non inseguii la persona misteriosa, non ne avevo la forza: il peso della stanchezza e della situazione mi avevano investita insieme; non sapevo dove mi trovavo, non sapevo il motivo per cui fossi lì e non avevo idea di come uscirne... e il timore che presto avrebbero cercato di farmi del male si aggirava ai confini della mia mente, tentando di deragliare il filo dei miei pensieri.
Costringermi a mantenere la calma non era mai stato così difficile e mi stupiva non poco il fatto che non fossi ancora uscita di testa. Mia madre aveva già scoperto che ero sparita? Aveva capito cos'era successo? E se quelle persone avessero fatto del male ai miei genitori? Non potevo sopportare l'idea di perderli, non loro.
«Dannazione» sussurrai, aprendo l'uscio ed entrando a testa bassa in bagno.
Dalla parte opposta si trovava una piccola finestra rettangolare, alta e stretta, la cui persiana era calcata di tre quarti, permettendo a un solo spiraglio di luce di rischiarare la stanza.
Mi affrettai a chiudere a chiave la porta e inalai il profumo dolciastro proveniente dalla vasca. L'acqua era ancora bollente. Mi spogliai in fretta, ignorando la paura che mi diceva di correre verso la finestra e buttarmi giù. Ero al primo piano e non sapevo dove mi trovavo. Avevo bisogno di più informazioni, prima di mettere in atto la mia fuga, e chiudere gli occhi per qualche minuto mi avrebbe aiutata. Dovevo pensare a mente lucida a come avrei fatto a definire la mappa mentale della casa e a come, nel bel mezzo della notte, sarei scappata. Non sarebbe stato un gioco da ragazzi, ma speravo di essere furba abbastanza da riuscire nell'impresa.
Nel frattempo, dovevo stare al gioco.
«Ce la farò» sussurrai fra me e me quando fui già dentro la vasca, il capo poggiato contro il bordo e gli occhi socchiusi. «Sono abbastanza forte da farcela.» Non me ne accorsi nemmeno, quando – nella quiete della stanza – mi addormentai.
* * *
Un colpo secco mi riportò alla realtà.
Inspirai con violenza, emergendo all'istante dalla vasca e mettendomi seduta. Mentre i miei polmoni si allargavano e contraevano strinsi le mani attorno al bordo di ceramica e rabbrividii; l'acqua era ormai fredda e la mia pelle ricoperta di grinze. Dalla porta giungeva un energico bussare, accompagnato da una voce femminile che urlava cose a me incomprensibili: «Ungfrú, líður þér vel?!»
Sbattei le palpebre per qualche secondo, le labbra socchiuse mentre tentavo di ricordare cosa fosse successo. Quando mi guardai attorno e riconobbi la stanza fu come se un secchio di acqua gelata mi fosse stato rovesciato addosso. Rischiai di annegare in quella consapevolezza: non mi trovavo a casa. Era tutto vero.
«Cazzo» sussurrai, passandomi il palmo destro sul viso. Non appena sfiorai le ferite sul tendine mi sfuggì un'altra imprecazione: nei punti in cui le unghie erano penetrate nella carne c'erano delle mezzelune dal colore rosa vivo. Almeno non c'era più traccia di sangue.
E intanto, la voce continuava: «Fröken, þetta vekur mig áhyggjur!» Sembrava disperata, mentre colpiva la porta con insistenza.
«Kadotus» mormorai, uscendo in fretta dalla vasca. Afferrai al volo l'accappatoio, piegato con cura sopra al mobile bianco pieno di cassetti alla destra del lavabo. Il tessuto era soffice.
«Zoë, Zoë, svaraðu!»
«Arrivo!» urlai di rimando, accostandomi alla porta. «Cristo, arrivo» aggiunsi in un borbottio mentre giravo la chiave.
Non appena l'uscio si aprì una figura alta e snella irruppe nella stanza come un tornado, costringendomi a retrocedere per evitare di cadere all'indietro. Una volta dentro richiuse la porta e premette l'interruttore della luce; il lampadario rotondo che pendeva sopra alle nostre teste prese vita, accecandomi. Non mi ero accorta che, dalla finestra, non entravano raggi di sole. Quanto tempo avevo passato dentro alla vasca? E come diavolo avevo fatto a vedere in quella penombra? Dovevo averla battuta davvero, la testa.
«Fyrir frábæru Atepa, ég hélt að eitthvað hefði komið fyrir þig! Ekki gera það aftur, Dimitar myndi drepa mig ef eitthvað kæmi fyrir þig!» esclamò gesticolando.
La guardai con gli occhi sbarrati, senza capire una virgola. La osservai dall'alto in basso: aveva capelli completamente bianchi e un pallido viso rotondo, con un dolce nasino a patata; ma furono i suoi occhi a lasciarmi senza fiato. Erano rossi come il sangue.
La ragazza dovette rendersi conto della mia confusione, perché spalancò la bocca ed emise un verso disperato, portandosi le mani alla testa. «Me serva!» gridò, in un inglese stentato. «Servizio padrone! Tu capire?»
Deglutii. «Sei... una delle domestiche?» chiesi aggrottando la fronte.
«Sì, serva io!» si illuminò. «Nome mio è Áshildur! Håvard parlatomi di me?»
«Se Håvard mi ha parlato di te? Sì, ti ha nominata. Riesci a capire quello che dico?» la guardai tentando di carpire qualche informazione.
«Io capire, no parlare buono.» Sembrava fare parecchia fatica, fra una parola e l'altra trascorrevano vari secondi, in cui guardava verso il soffitto e si grattava la pelle sotto al labbro, dove si era fatta strada una macchiolina rossa. «Perché tu...» avvicinò le mani al viso e fece un gesto simile a un conato di vomito: aprì i palmi, rivolti verso l'alto, e dalla propria bocca li abbassò fino al mio petto. «Si dice, no? Tu... tu no rispondevi. Motivo tu no rispondere? Io temevo!»
«Stavo dormendo» spiegai, mimando un sonnellino. «Mi sono addormentata nella vasca, ti ho sentita solo quando hai cominciato a urlare.» Mentre parlavo – lentamente, per assicurarmi che capisse appieno – continuai a studiarla. Avvolta in un abito azzurro dalla gonfia gonna in pizzo sembrava una delicata fatina delle nevi. Mi chiesi come facesse a mantenersi ritta, con i trampoli che portava ai piedi, i quali la rendevano molto più alta di me, quando non doveva superare il metro e settanta.
«Tu perdona me. Io preoccupata» replicò, abbassando le spalle affranta.
«Non devi chiedermi scusa. È colpa mia, non avrei dovuto addormentarmi.» Ci scrutammo reciprocamente di sottecchi. «Posso... posso chiederti da dove vieni? La lingua che stavi parlando...»
Mi interruppe: «Mia madre terra Islanda, io isl... is...»
Vedendola in difficoltà l'aiutai: «Sei islandese.»
«Sì, esatto! Io is-lan-dese!» Si illuminò, quando riuscì a pronunciare la parola.
«Parli il finlandese, per caso?» tentai.
«Solo parole ciao-e-indicazioni.» Mosse le mani mimando una camminata.
«Non importa» feci un gesto per scansare la questione. «Sai che ore sono?»
«Cinque pomeriggio, più metà. Fuori buio è temporale.»
Mi accigliai. Avevo dormito un bel po'. «Okay. Puoi accompagnarmi a... qualsiasi sia il posto in cui hanno deciso di tenermi? Mi servirebbero anche dei vestiti.»
«Abiti! Sì! Io avere!» Si voltò verso il mobile alle sue spalle e prese un abito, che per via del suo brusco ingresso non avevo notato. «Questo tuo, primo di tanti! Spero sta buono, non mio.»
Presi l'abito dalle sue mani e lo spiegai di fronte a me. Lo scrutai con occhio critico, poco sicura di volerlo indossare. Non mettevo in dubbio che fosse un bel capo, di una stoffa pregiata, ma non ero certa potesse adattarsi al mio stile: di colore blu cobalto, aveva lunghe maniche di pizzo ricamate a formare varie rose, una lunga gonna non troppo gonfia e un corpetto decorato da inserti in metallo. Davanti, sul collo, v'era uno strato di stoffa liscia al tatto, probabilmente raso, che andava a formare due lembi simili ad ali di angelo e da cui scendevano due lacci da legare a fiocco davanti al seno. Le spalle erano a palloncino e sopra la gonna c'era uno strato di pizzo identico a quello delle maniche. Non mi sarei stupita di vederlo addosso a Vanessa Ives in una puntata di Penny Dreadful.
Peccato che noi non ci trovassimo nel 1800.
«Scusami...» dissi ad Áshildur. Lei mi guardò sorridendo, non notando la mia perplessità. «Ma io dovrei indossare questo?»
I suoi occhi si dilatarono. «Questo no piace? Furir Atepa, io no volere arrabbiarti! Perdono, ma richiesto Dimitar tu vestire così!»
«Intendi dire che Dimitar ha scelto questo abito per me?» inarcai un sopracciglio.
«No, no, io sbagliato dire. Lui chiede stile per cena.»
«Cioè, fammi capire... lui vuole che mi vesta in questo... modo?» lanciai un'occhiata poco convinta al vestito.
«Sì, questo dire. Lui chiede, noi facciamo. Padrone, sì, padrone.» Quando pronunciò quell'ultima frase la sua voce era calma e priva di pause, ma i suoi occhi rossi mi guardavano dritta in faccia, animati da una lue che mi ricordava tanto me stessa dopo l'attacco da parte di Richard. Avrei potuto riconoscerlo ovunque: quello era odio.
Il pensiero che Áshildur non volesse lavorare in quella casa mi sfiorò la mente e diede una vampata al mio coraggio, alimentandolo come avrebbe fatto legna asciutta in un camino acceso. Era possibile che Áshildur potesse aiutarmi a scappare?
«Ed è... un bravo padrone di casa, Dimitar?» indagai, cercando di non soffermarmi su come tutti lo definissero "padrone".
Lei rimase in silenzio per qualche istante, analizzando la mia frase con le labbra serrate. «... Dimitar?» disse infine. «Io... Sì, buono, lui. Lui permette molto, casa bella, io amiche serve. Loro fantastiche!» Annuì con foga, ma qualcosa – forse la veemenza con cui parlò, forse lo sguardo sfuggente – non mi convinse. Ero sempre più certa che tutti quelli che incontravo in quella casa non me la contassero giusta, che fossero a conoscenza di segreti che sarei stata ben lieta di apprendere – al contrario di quel che diceva Móreen –, ma che nessuno fosse deciso a rivelare per timore di... qualcosa. O qualcuno.
C'era sempre quel qualcosa, in mezzo: qualcosa che non quadrava con la situazione, qualcosa che non quadrava con Victor, qualcosa che mi stava facendo perdere quel poco di calma che ancora mi restava.
Mi tornarono alla mente le parole di Richard Bach, lo scrittore preferito di mio padre, e riflettei su quanto fossero appropriate alle circostanze. "Non dar retta ai tuoi occhi, e non credere a ciò che vedi: gli occhi vedono soltanto ciò che è limitato." Pensai si trattasse proprio di questo: qualcosa mi stava sfuggendo, qualcosa che tutti parevano conoscere ma che io non ero in grado di afferrare, perché vedevo senza guardare. Per scoprire la verità avrei dovuto analizzare non solo il luogo, ma anche le persone che vi abitavano. Dovevo trovare l'elemento mancante, il pezzo del puzzle che non s'incastrava con gli altri, e quella sera avrei avuto l'occasione giusta per farlo.
D'un tratto quell'abito non mi dispiacque più molto.
«Va bene» risposi, fingendo di credere alle parole di Áshildur. «Puoi farmi strada?»
«Sicura! Io conoscere strada. Tu prima vestire?»
«Sì, giusto, prima mi vesto. Potresti uscire dal bagno per qualche minuto?» Lei fece un cenno e si affrettò a uscire, salutandomi con la mano. Sembrava sempre di più una Trilli troppo cresciuta.
Rimasta sola sospirai, esausta per via di tutti quegli incontri e della velocità con cui mi pareva si stessero verificando gli eventi. Ogni secondo, ogni minuto, venivo sballottata a destra e sinistra. Non provavo più nemmeno rabbia, solo tanta, troppa confusione.
Avvicinandomi al lavabo e allo specchio mi pizzicai l'avambraccio, per essere sicura di non star dormendo. No, ero sveglia.
«Dannazione» sussurrai al mio riflesso, portando lo sguardo nel mio mentre con le dita stringevo il bordo del lavandino. Lo specchio riportava l'immagine di una ragazza distrutta, con delle occhiaie profonde e un tremore al labbro che – più mi osservavo – più diventava insistente. Ero pallida e avevo i capelli scompigliati, legati in diversi punti in nodi che mi parevano indistricabili. La bocca screpolata, decorata dal piercing, completava il quadro del mio aspetto disastrato.
«Sei proprio finita nella merda, stavolta, Zoë» sussurrai, il volto più vicino al riflesso. «Sei proprio finita nella merda.»
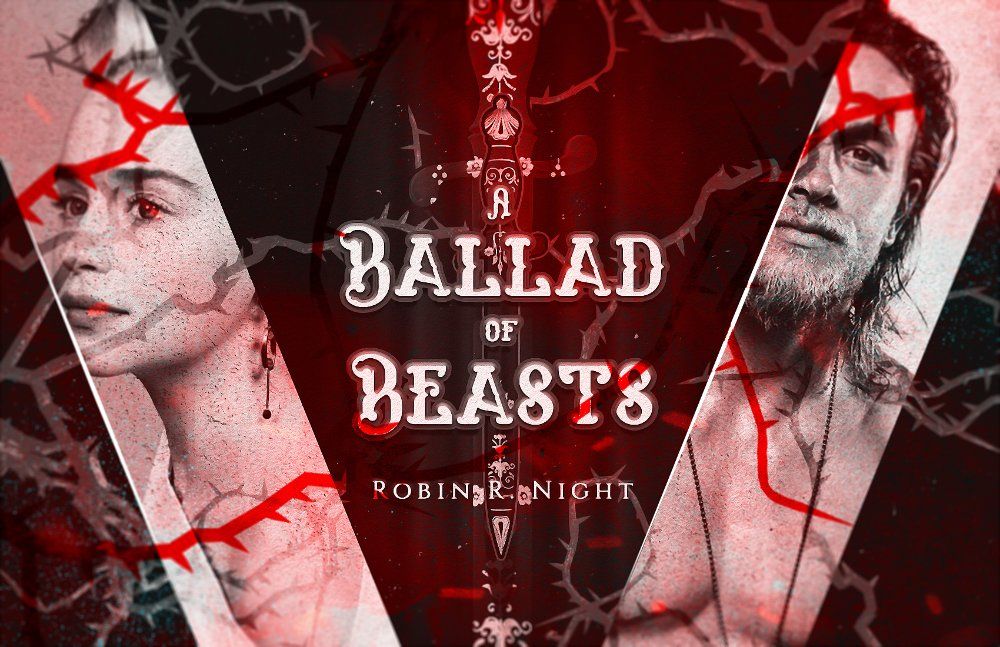
Beta: Sayami98
Banner: Saintjupiter
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro